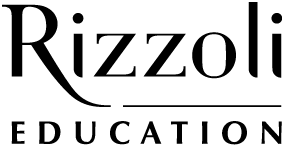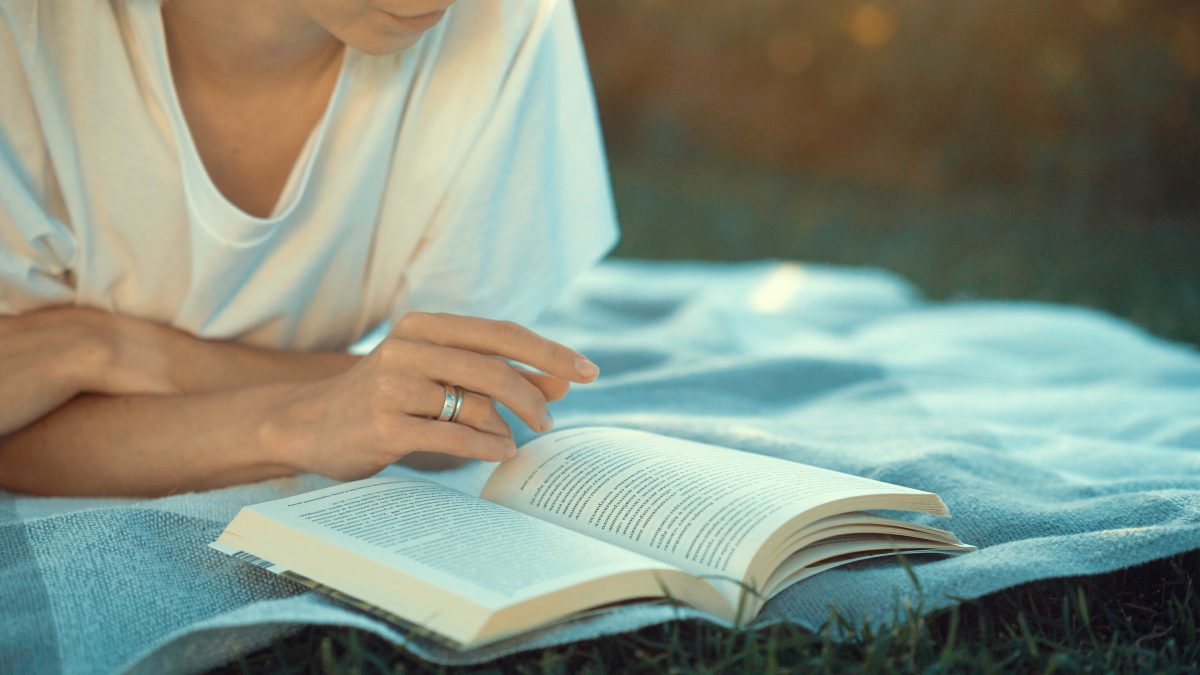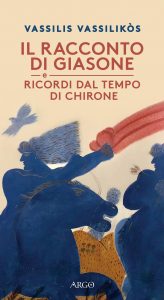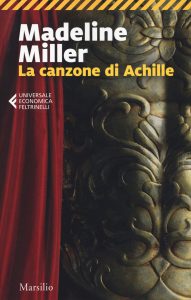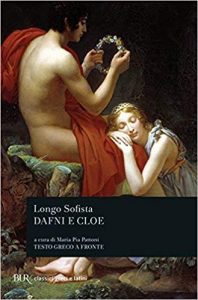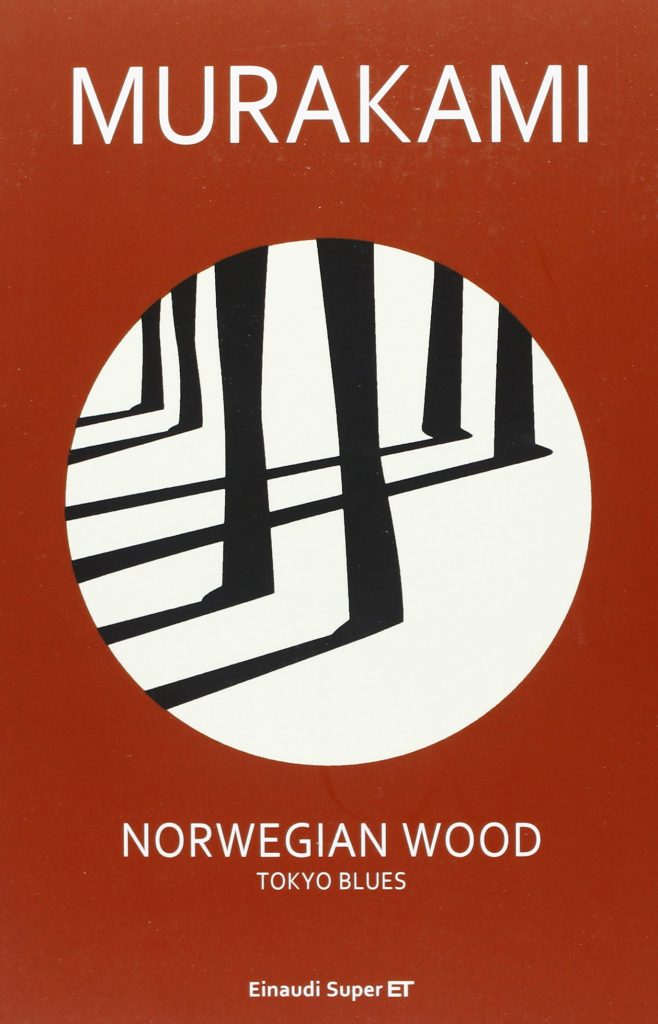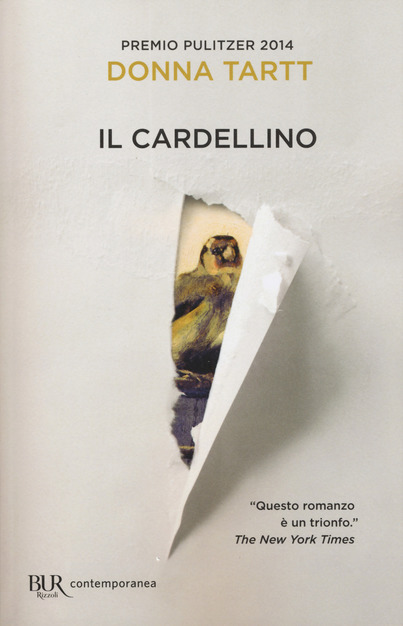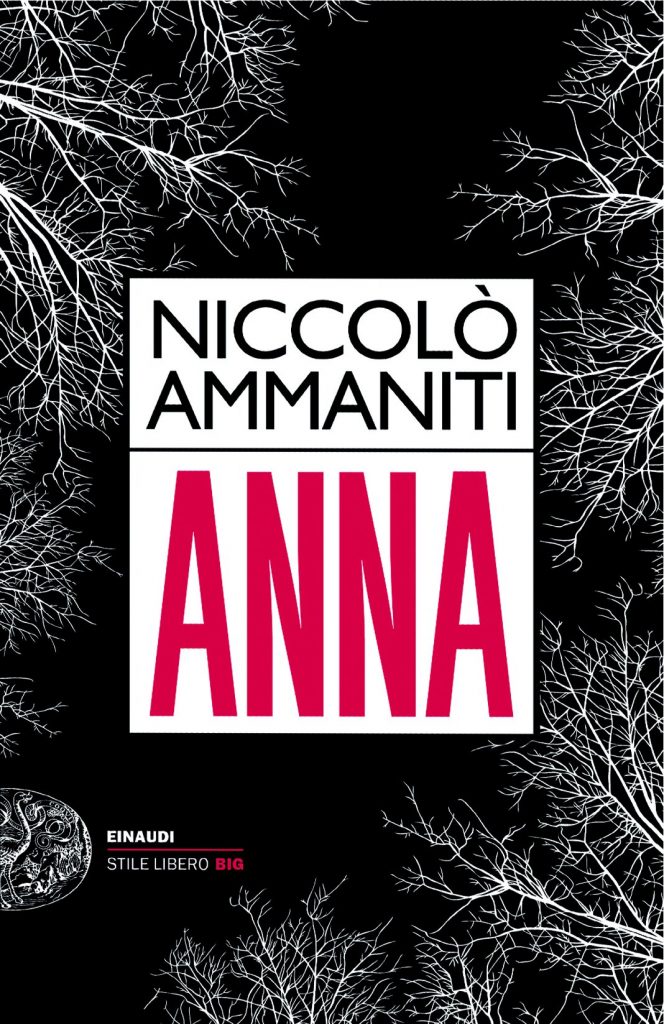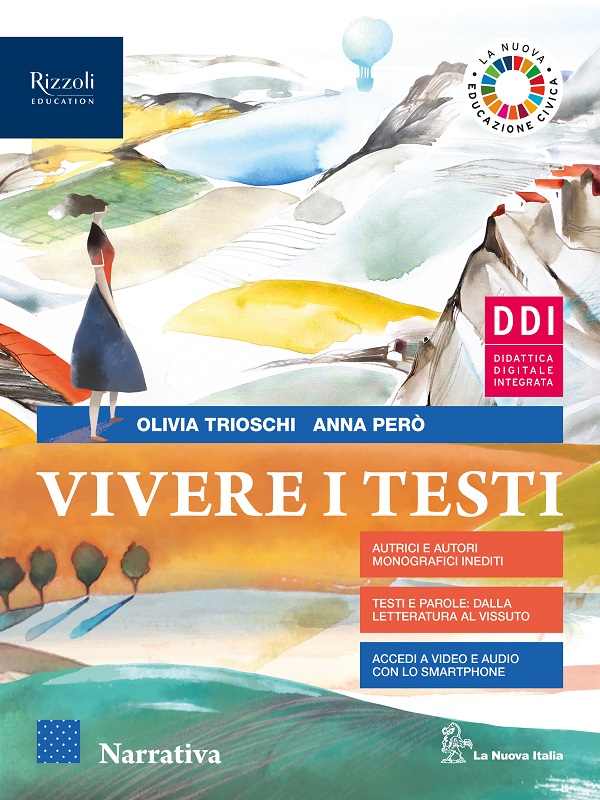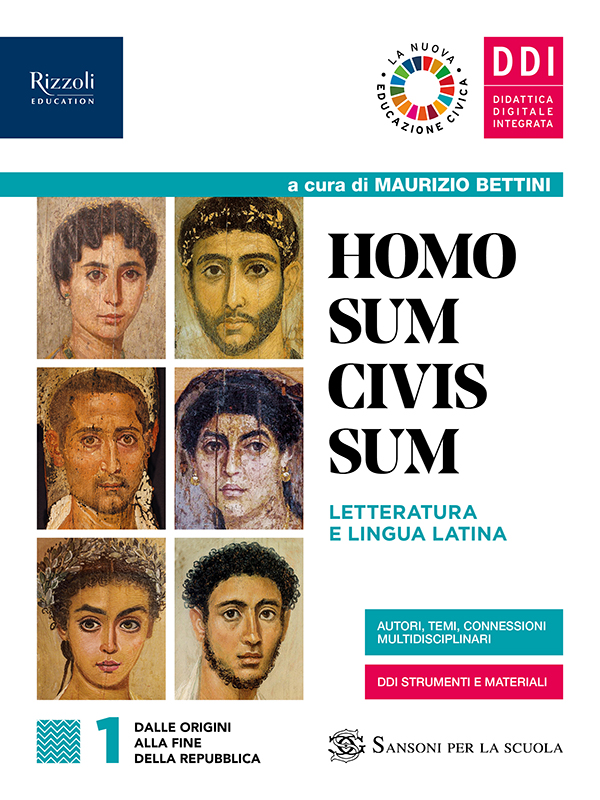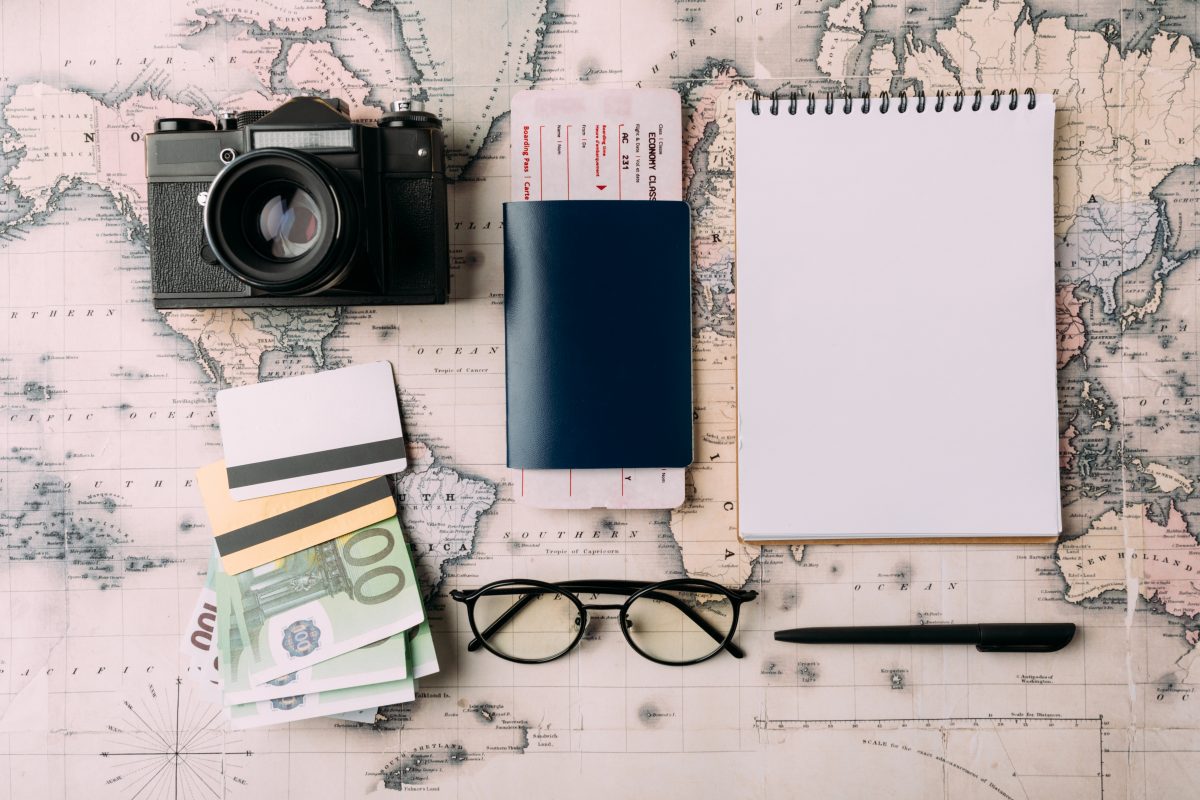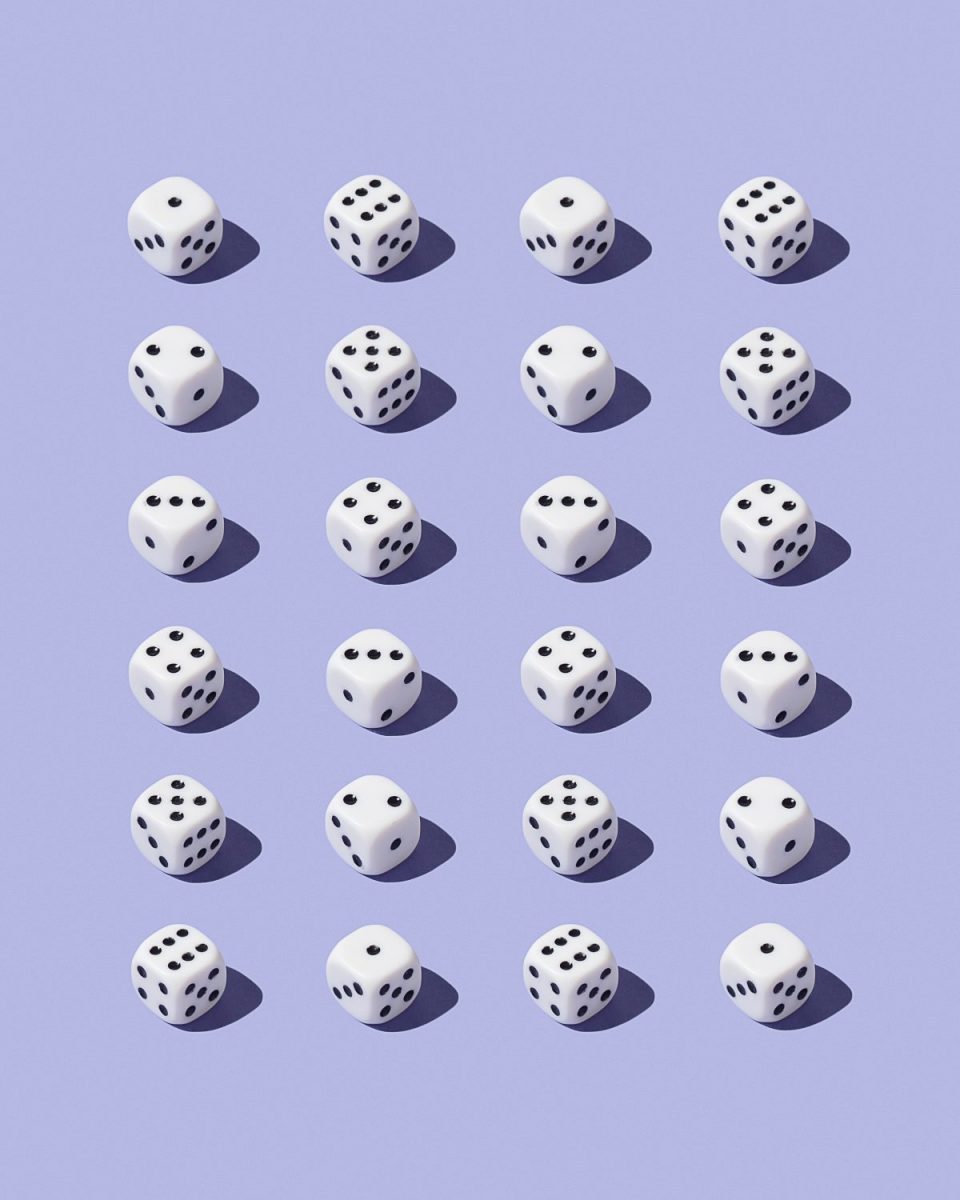“Siccome l’arte è sempre un’espressione della società, anche lei cambia e così cambia il nostro e il suo rapporto con noi”
Francesco Bonami
Grazie al progressivo allentamento delle misure restrittive, con la bella stagione alle porte e provati dalle lunghissime chiusure di cinema, teatri, musei e gallerie, sarà fisiologico – nei giorni a venire – cercare di evadere dalle proprie mura domestiche alla ricerca di esperienze culturalmente stimolanti e possibilmente all’aria aperta.
Molte istituzioni – durante i mesi di chiusura – hanno traslato la propria proposta su canali online con visite virtuali ad altissima definizione, laboratori interattivi, talk e interviste inedite ed ora hanno riaperto loro portoni seppur non con poche difficoltà. Sono le mostre e le rassegne temporanee programmate nei musei e gallerie ad aver subito il colpo d’arresto più significativo, con progetti pronti da mesi (alcuni da più di un anno) che vedranno la luce -se tutto andrà bene- in autunno.
Come possiamo consolarci in attesa che tutto riprenda a pieno regime, coniugando la nostra sete di conoscenza, la ricerca di stimoli intellettuali e la spensieratezza e tranquillità della quale necessitiamo oggi? Ci sono dei luoghi open air – spesso al di fuori dei tradizionali tour mainstream- che sono a tutti gli effetti parte del patrimonio storico-artistico nazionale: abbiamo a disposizione le più belle collezioni del mondo nei nostri musei e tendiamo di riflesso a sottovalutare contenitori d’arte meno istituzionalizzati , che paradossalmente interessano di più ai turisti stranieri che italiani, i quali generalmente faticano a sperimentare l’arte contemporanea, cadendo nel pregiudizio che sia per pochi.
Sono i parchi artistici e i giardini di sculture le realtà che coniugano al meglio il concetto di arte e natura, dove l’arte trova nuovo spazio per essere progettata, esposta, raccontata e vissuta, sposandosi con la botanica e l’architettura del paesaggio, in un rispettoso dialogo con l’ambiente circostante. Caratteristica comune è il carattere della vastità della superficie dei parchi-museo: troviamo molto frequentemente opere di dimensioni considerevoli, di forme e colori bizzarri e soprattutto interattive, calpestatili, attraversabili, tangibili, a volte addirittura “suonabili”. Rendere l’arte qualcosa di cui si può fare esperienza fisica diretta favorisce la comprensione e l’immedesimazione necessaria all’elaborazione personale per renderla un’esperienza propria e capire al meglio il messaggio dell’artista stesso.
La visita di un parco artistico è quindi un’attività adatta a chiunque: adulti, bambini, ragazzi, cultori della natura e della botanica, esperti d’arte, scolaresche o gruppi di anziani, Instagramers per professione o diletto, turisti curiosi o viaggiatori occasionali. Anche chi fatica a entrare in un classico museo perché lo considera un luogo buio, polveroso e noioso o chi pensa “Io di arte non ci capisco niente” può fare esperienza dell’arte in un modo totalmente diverso, libero, personale ed emotivo.
Parchi artistici

Posizionati in luoghi panoramici strategici, incorniciati da elementi naturali che caratterizzano il paesaggio circostante, i parchi artistici sono presenti su tutto il territorio italiano. Rigorosamente open air, lontani dai grossi centri cittadini e dai circuiti tradizionali che smuovono grossi flussi di persone, sono luoghi che regalano allo spettatore un tipo di esperienza artistica unica, diretta e coinvolgente delle opere.
Alcune raccolte sono frutto dalle donazioni di mecenati innamorati dell’arte, filantropi e spesso amici degli artisti, che poi “regalano” alla comunità la possibilità di fruirne, aprendo piccoli scrigni di opere preziose e uniche nel loro genere. Altri luoghi sono stati scelti, riqualificati e convertiti dagli artisti con ambiziosi progetti di intervento artistico-sperimentale.
Le opere – in dialogo con l’ambiente circostante- sono nella maggior parte dei casi site-specific, ovvero pensate e create proprio per il determinato luogo in cui si trovano. In questo modo, lo spettatore viene invitato a reinterpretare il luogo in funzione dell’opera e, allo stesso tempo, a riconoscere, attraverso la lettura del luogo, il significato dell’opera stessa. Leggendo progetti e interviste ad artisti ambientali contemporanei si evince come molto spesso sia il luogo a suggerire all’artista l’intervento da eseguire e non viceversa; con le residenze d’artista (progetti che prevedono che l’artista soggiorni per un periodo medio-lungo in un determinato luogo nel quale poi lavorerà, cosi da poter progettare in totale sintonia senza interferenze ambientali esterne) il dialogo tra ambiente e artista si fa intimo e direttamente esperienziale.
Il binomio arte e natura ci accompagna sin dal 1970, anno della nascita del movimento della Land Art, nel quale un gruppo di artisti americani, definendosi fanatici della natura, decisero che l’arte avrebbe potuto uscire dalle sale del museo (definito metaforicamente dal critico d’arte Brian O’Doherty “cubo bianco”, in riferimento alle pareti bianche, asettiche, tipiche della esposizione modernista, nelle quali il pubblico vive un’esperienza dell’arte fuori dal tempo e dal luogo) per invadere la terra stessa, attraverso una serie di opere-interventi sui territori naturali in spazi incontaminati. Come ci racconta il grande critico e curatore Gillo Dorfles: “nasce in questi anni la volontà di fomentare il senso di appartenenza ad un luogo, in seguito a una presa di coscienza da parte della società in relazione all’ansia di dominazione smisurata dell’uomo sulla natura, che ha portato ad un allontanamento emozionale ed affettivo rispetto alla nostra condizione di esseri umani.. è comunque un intervenire sulla natura, su elementi che presentano un ordine naturale e che, da tale intervento per mano dell’artista, sono sconvolti ed incrinati”. Questo movimento artistico decise inoltre di indagare attraverso l’arte, il rapporto tra individuo e l’ambiente naturale percepito come sfondo primordiale della vita umana.
Questa riflessione risulta estremamente attuale e ci porta a ragionare sul tema della sostenibilità e dell’impatto del lavoro dell’artista sulla natura; l’intervento dell’uomo-artista si “riduce” in questo caso a creare con ciò che la natura gli mette a disposizione, senza stravolgerla con azioni artificiali irreversibili ma intervenendo su di essa attraverso un dialogo sottile, leggero, pieno di rispetto e gratitudine. É interessante constatare il carattere effimero delle opere costantemente esposte all’aria aperta, che vengono cosi trasformate nel tempo dagli agenti atmosferici – quindi dalla natura stessa – e che concorrono per trasformarsi in un prodotto intangibile frutto del processo naturale e della collaborazione artistica tra uomo e natura stessa.
Purtroppo manca ancora un network che possa raggruppare sistematicamente queste realtà che sono spesso a gestione privata diretta, senza fondi né stanziamenti economici dedicati dal Ministero dei Beni Culturali, difficili da inquadrare in maniera unitaria a livello legislativo e organizzativo.
7 Musei open-air focus
TRENTINO
ARTE SELLA – Pergine Valsugana (Trento)
Arte Sella nasce in forma sperimentale nel 1986, quando un gruppo di amici residenti a Borgo Valsugana si ritrova in Val di Sella, nel giardino di Villa Strobele, a immaginare di coniugare arte contemporanea e natura. Inizia così un periodo di contatti con istituzioni culturali locali, con la popolazione e con artisti, principalmente stranieri. Nascono sodalizi forti e vengono stabiliti alcuni principi cardine, che tuttora ispirano l’attività di Arte Sella:
– L’artista non è protagonista assoluto dell’opera d’arte ma accetta che sia la natura a completare il proprio lavoro;
– La natura va difesa in quanto scrigno della memoria;
– La natura non viene più solo protetta, ma interpretata anche nella sua assenza: cambia quindi il rapporto con l’ecologia;
– Le opere sono collocate in un hic et nunc e sono costruite privilegiando materiali naturali. Esse escono da paesaggio, per poi far ritorno alla natura
Tra gli interventi più spettacolari si ricorda la cattedrale vegetale di Giuliano Mauri costruita con più di tremila rami intrecciati nelle forme di una cattedrale a tre navate, con ottanta colonne alte 12 m; all’interno di ogni colonna è collocata una pianta di carpino, che nell’intenzione dell’artista, una volta cresciuta dovrebbe prendere il posto della struttura attuale, destinata a marcire e a scomparire. Altre opere installazioni site-specific di Jakko Pernu , Cornelia Konrads Isabella Bordoni, Studio Azzurro e tanti altri.
http://www.artesella.it/it
artesella
LOMBARDIA
ROSSINI ART SITE – Briosco (Monza e Brianza)
Rossini Art Site è un parco di sculture di 10 ettari, adagiato tra i colli briantei, nel cuore verde del parco della Valle del Lambro. Proprio la sua posizione suggestiva ed il panorama mozzafiato che si schiude sulle Alpi con vedute incredibili e mutevoli, l’hanno reso il luogo ideale scelto dall’imprenditore e mecenate Alberto Rossini per ospitare la sua collezione di arte del Secondo Novecento, tra cui sono spiccano opere di artisti come Pietro Consagra, Bruno Munari, Giт Pomodoro, Fausto Melotti, Grazia Varisco, per citarne alcuni. Fulcro del luogo и certamente il pavilion di accesso al parco, progettato dallo studio SITE e dall’architetto newyorkese James Wines, esponente della Green Architecture, maestro di design ambientale e dell’architettura organica, che ha dato vita a Briosco ad un progetto in grado di dialogare perfettamente con il territorio circostante, integrando arte, ambiente e architettura in un unico concetto.
http://www.rossiniartsite.com
rossiniartsite
PIEMONTE
– ORME SU LA COURT- Asti
Luogo unico nel suo genere, la tenuta La Court si trova all’interno di una delle zone che compongono il cinquantesimo sito Unesco d’Italia: i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
Venti ettari vitati, tre cascinali, due colline: il più esteso museo a cielo aperto in vigna, monumento in continuo aggiornamento dove arte, paesaggio e vino dialogano ininterrottamente, offrendo ai visitatori una delle esperienze di land art e panorama enologico.
Le scenografie paesaggistiche sono state progettate da Emanuele Luzzati che qui ha lasciato in eredità le sue sculture, organizzate lungo un percorso fiabesco dedicato agli elementi: Terra, Acqua, Aria e Fuoco.
lI parco è costellato di opere di artisti di fama internazionale, tra cui spiccano gli interventi di Ugo Nespolo, Giancarlo Ferraris e Chris Bangle. Elementi immaginifici e iconici che immergono il passante in atmosfere arcaiche e fantastiche, ragionando sul rapporto e l’armonia tra uomo e natura, creando spazi meditativi e punti d’osservazione.
https://www.michelechiarlo.it/art-park-la-court/
michelechiarlo
TOSCANA
IL GIARDINO DI DANIEL SPOERRI – Seggiano (Grosseto)
All’inizio degli anni ’90, l’artista svizzero Daniel Spoerri acquistò una tenuta sulle pendici del Monte Amiata, a circa 60 km a sud di Siena. Nelle mappe antiche questo luogo era denominato »Paradiso«, forse per il clima mite che favorisce una vegetazione rigogliosa di numerosissime specie. Si potrebbe quindi giustamente parlare di un »giardino paradisiaco«. Qui Spoerri si è accostato alla natura e ha iniziato ad installare sculture, trasformandolo in un vero museo a cielo aperto che attualmente ospita 113 installazioni di 55 artisti su un territorio vasto circa 16 ettari, ricchi di bosco, macchia mediterranea ed olivi.
http://www.danielspoerri.org/giardino/it/giardino-daniel-spoerri-italia/
GIARDINO DEI TAROCCHI – Capalbio (Grosseto) Da un’idea nata in viaggio dell’eclettica artista francese Niki de Saint Phalle e ispirato al Parc Guell di Gaudì a Barcellona, il »Giardino dei Tarocchi« è uno dei giardini in Toscana più magici. Assemblato per quasi 20 anni, dal 1979 fino al 2002, anno della morte della sua ideatrice, il parco monumentale è composto da 22 enormi sculture, di cui alcune abitabili, coloratissime e ricoperte di mosaici in vetro e ceramica ispirate ai Tarocchi e alla loro simbologia. La stessa artista ha più volte sostenuto che il giardino, come la sua vita, è proprio come il gioco di carte dei Tarocchi: non si sa mai quale ci si può trovare davanti. Nel Giardino infatti non c’è nessun percorso obbligato, ma si è liberi di vagare come in un sogno, sogno a cui hanno potuto collaborare anche tanti grandi artisti di arte contemporanea internazionali.
http://ilgiardinodeitarocchi.it
ilgiardinodeitarocchi_official
SICILIA
FIUMARA D’ARTE – Castel di Tusa (Messina)
L’idea di “Fiumara d’Arte”, ubicata nel territorio della città metropolitana di Messina, nasce nel 1982 quando -scosso dalla perdita del padre- Antonio Presti, che già collezionava arte contemporanea, pensa di dedicare un monumento alla sua memoria e si rivolge allo scultore Pietro Consagra. Immagina fin da subito di non farne un semplice fatto privato, una stele del proprio giardino, ma di donare la scultura alla collettività, collocandola alla foce della fiumara. Oltre a Consagra, possiamo ammirare la celebre finestra sul mare di Tano Festa, Stanza di barca oro di Hidetoshi Nagasawa e altre dieci opere di artisti contemporanei ubicate lungo gli argini del fiume Tusa, oggi a carattere torrentizio, che sfocia nella costa tirrenica.
http://www.ateliersulmare.com/it/
ateliersulmare
CALABRIA
– MUSABA FONDAZIONE SPATARI/MAAS- Mammole (Reggio Calabria)
Nik Spatari e Hiske Maas sono una coppia di creativi che da cinquant’anni, hanno scelto di vivere a Santa Barbara, un pianoro che guarda al Mar Jonio, che quando sono arrivati era sepolto dai rovi e dalla dimenticanza, che hanno poi trasformato nell’unico museo all’aperto calabrese, uno dei pochi in Europa che è anche laboratorio di sperimentazione artistica e di tutela del paesaggio. Il parco museo laboratorio si sviluppa (nei suoi 70000 metri quadrati) attorno ai resti dell’ antico complesso monastico del x secolo di Santa Barbara, all’interno del territorio dell’ente Parco Nazionale d’Aspromonte; lungo tutto il parco le opere d’arte si susseguono tra sculture, istallazioni, mosaici realizzati in calcestruzzo, piastrelle policrome, pietra, metallo e materiale riciclato. Grande attenzione anche all’aspetto botanico con centinaia di piante e arbusti di varie specie circondati dall’antico uliveto dell’Acrocoro.
https://www.musaba.org/#parco
musaba_parco_laboratorio_
Appendice di approfondimento
I giardini botanici in Italia sono moltissimi: alcuni fanno da sfondo a dimore storiche e palazzi, altri sono una sorta di culla in cui viene preservata la biodiversità vegetale. Tutti hanno in comune la natura che dà spettacolo e che trasforma il giardino in un luogo per l’eterna contemplazione della bellezza.
GIARDINI e patrimonio botanico
Precursore della concezione del giardino come “opera d’arte” fu Claude Monet che con l’acquisto del giardino di Giverny, nella campagna normanna, realizzò il sogno di una vita creando il suo paradiso terrestre, che fu di fondamentale ispirazione per la sua serie di dipinti sulle ninfee.
Nel 1997 Judith Wade, (CEO di Grandi Giardini Italiani), ha l’idea di creare un network che si occupi delle promozione organizzata e permanente a livello nazionale del patrimonio artistico – botanico dei giardini Italiani. Nasce cosi GRANDI GIARDINI ITALIANI.
All’epoca il turismo culturale che riguardava i grandi giardini era considerato erroneamente dai più come un ramo minore, nonostante il clima favorevole e la stupefacente offerte di giardini visitabili non esisteva una vera promozione organizzata e permanente a livello nazionale per questa versante del turismo.
I giardini sono di svariate tipologie: giardino storico, giardino botanico, giardino paesaggistico, giardino moderno, giardino dell’arte.
Oggi nei Grandi Giardini Italiani si organizzano più di 700 eventi all’anno, tra cui la famosissima Caccia al Tesoro Botanico di Pasquetta, che viene organizzata contemporaneamente nei 140 giardini dislocati in 14 regioni.
Elenco completo dei giardini appartenenti al circuito, diviso per regioni e provincie:
https://www.grandigiardini.it/grandi-giardini-italiani.php
grandi_giardini_italiani