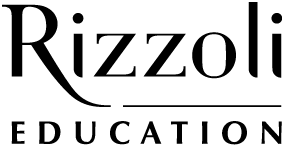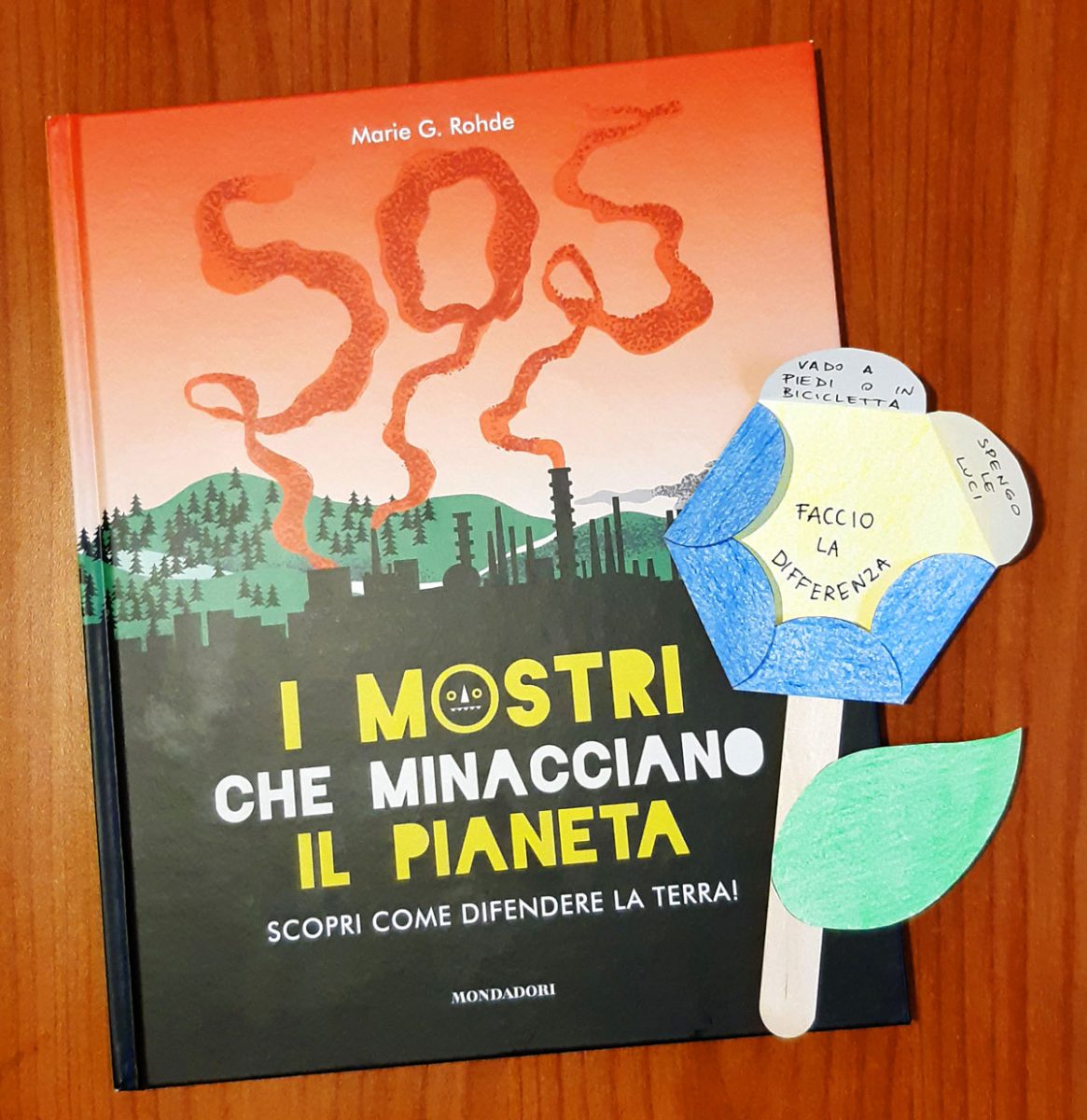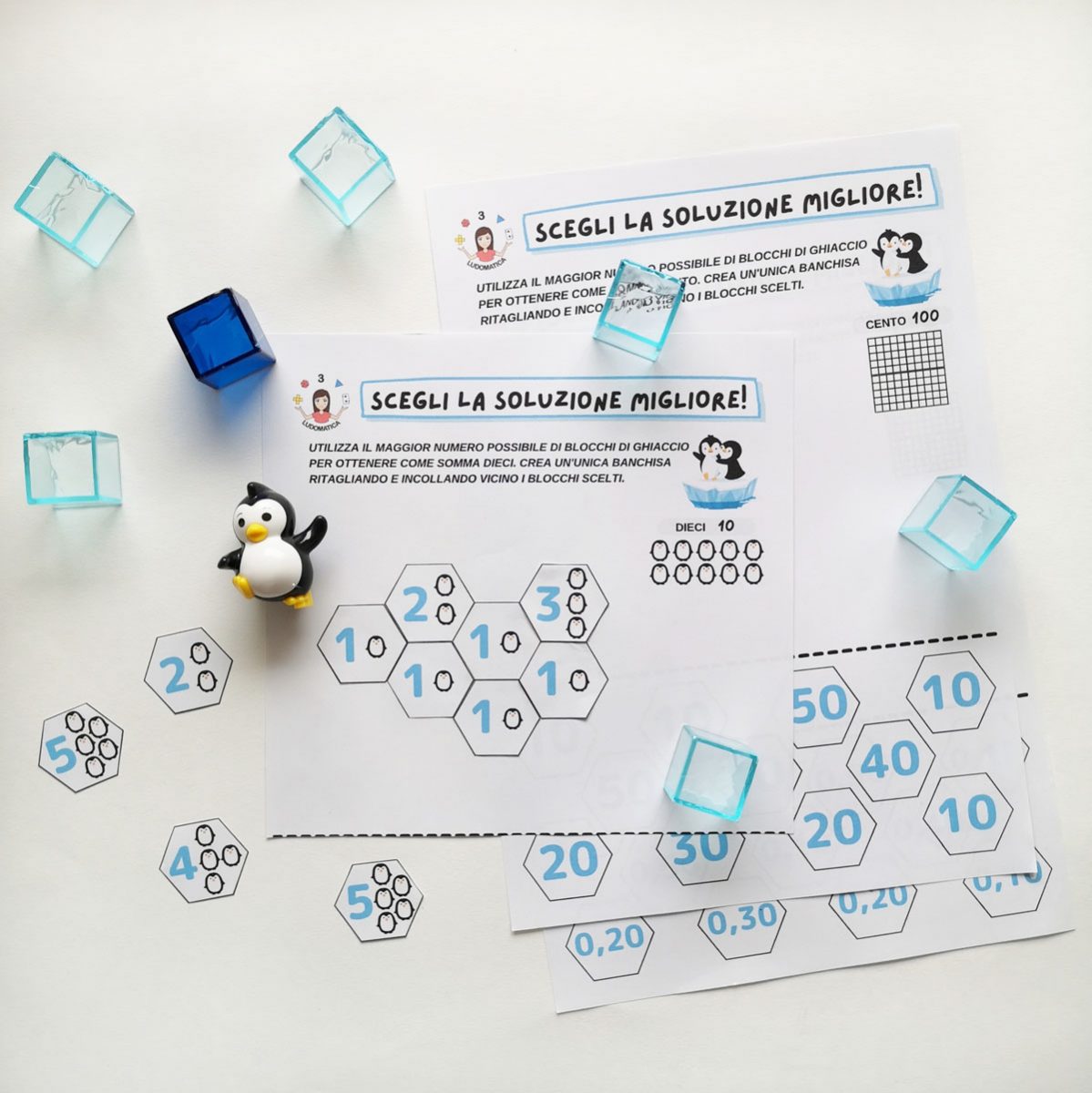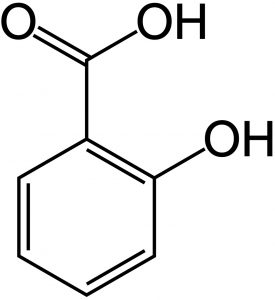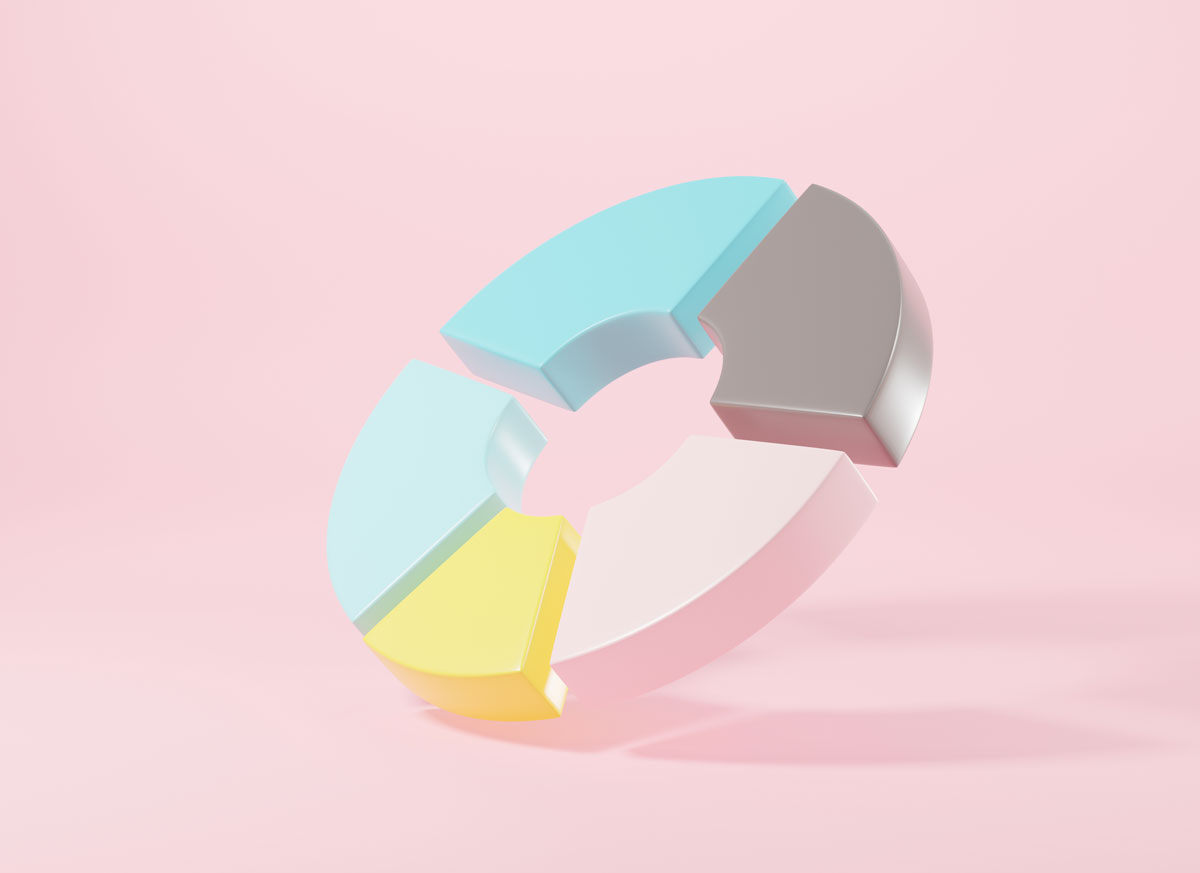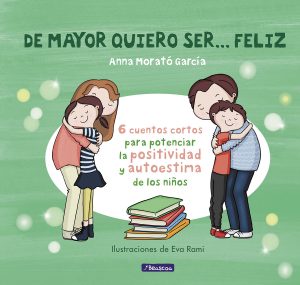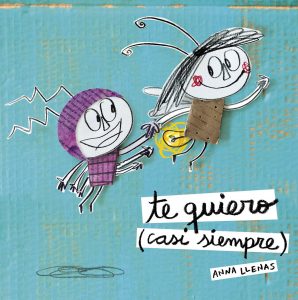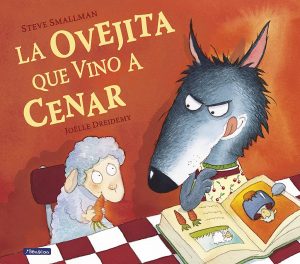I feudi – il feudalesimo, come si dice in alcuni manuali – sono uno degli argomenti più difficili dell’insegnamento della storia. Se si cerca in rete – o anche nei manuali e persino nelle pubblicazioni specialistiche – si trova molto, ma credo che si abbia anche l’impressione di una certa confusione. Da molte parti si legge che non è corretto usare l’espressione piramide feudale. Alcuni storici hanno persino proposto di abolire la parola feudalesimo. In questo articolo vorrei provare a sintetizzare alcuni suggerimenti, per chiarire perché certi modi di trattare l’argomento possano essere sbagliati, e avanzare alcune proposte che aiutino a inquadrare correttamente il tema dei feudi. Partiamo dagli errori più comuni.
Il primo riguarda senz’altro la piramide feudale. Con questa espressione ci si riferiva a una presunta gerarchia sociale che, sotto il sovrano, prevedeva l’esistenza di vassalli, di valvassori (vassalli di vassalli) e di valvassini (vassalli di vassalli di vassalli). Di norma, quando ancora compare nei manuali, la piramide feudale è usata per spiegare la società alla fine dell’Alto medioevo, indicativamente nei secoli IX e X, o anche XI, sebbene le cronologie difficilmente vengano chiarite con precisione dai libri di testo. Perché non va bene usare quest’espressione?
La prima critica riguarda l’articolazione gerarchica proposta, che è di fatto quasi del tutto assente dai documenti dell’epoca. La parola valvassini, in particolare, a mia conoscenza è nota soltanto attraverso un unico trattato giuridico del XII secolo, ma non compare mai nei documenti. Anche il termine valvassore, che pure è testimoniato, è piuttosto raro. E se proprio dovessimo essere pignoli, i valvassori dipendevano non dai vassalli, ma dai capitanei, una parola che compare sempre nei testi di XI e XII secolo.
Ma focalizziamo l’attenzione sull’aspetto che ci interessa: quello contenutistico. La piramide feudale trasmette l’idea che essere vassalli, valvassori o valvassini corrisponda alla collocazione all’interno della società: come nell’esercito, in cui si può essere generali, colonnelli, capitani e così via. Invece non era così: nella società dell’epoca non si era vassalli in assoluto, si era semplicemente vassalli di qualcuno. Non si tratta quindi di un ordine stabilito, ma di una relazione personale.
Non si acquisiva uno status sociale particolare per il fatto di essere signore di altri vassalli. Per questa ragione, alcuni storici hanno proposto di non pensare le relazioni feudali in termine di piramide, ma piuttosto di rete. Una rete di legami personali, che serviva a codificare le relazioni tra gli aristocratici. Un ulteriore problema riguarda il fatto che la piramide trasmette l’idea di una società immobile, con rigide articolazioni sociali. Oggi sappiamo che le reti di relazioni vassallatiche non imbrigliarono mai la società in rapporti immutabili di gerarchia. La società di IX e X secolo era infatti fluida: erano possibili scalate sociali. Lo stesso fatto di essere vassalli non implicava del resto, come abbiamo detto, uno status sociale particolare.
C’è una quarta e ultima controindicazione nel concetto di piramide feudale: la pervasività della piramide feudale. L’idea cioè che i legami feudali fossero diffusi in maniera capillare nell’impero di Carlo Magno e dei suoi successori. Per lungo tempo gli storici hanno creduto che l’intera società di IX e X secolo fosse rigidamente organizzata attraverso questo tipo di relazioni feudali, tanto da definirla come “società feudale” e da usare per quest’epoca l’espressione di “feudalesimo”. In diverse zone d’Europa, i rapporti feudali erano poco diffusi ed esistevano molti aristocratici che avevano beni soltanto in “allodio”, cioè in piena proprietà, senza avere alcuna relazione di dipendenza vassallatica da altri. E non per questo erano più o meno potenti dei vassalli.
È stato pure osservato che – anche dal punto di vista della cronologia – l’uso delle relazioni feudali (o forse sarebbe meglio dire vassallatiche), che indubbiamente può essere fatto a partire da Carlo, ebbe una diffusione molto maggiore nel corso del basso medioevo e persino in età moderna. Talvolta associato alla piramide feudale, o comunque alla società dell’epoca, troviamo un altro errore frequente: i “servi della gleba”, così come vengono indicati i contadini il cui destino era legato alla terra. I servi della gleba sarebbero infatti contadini che venivano venduti insieme alla terra, che quasi passavano di proprietà insieme ai beni fondiari. Persone dunque dalla libertà limitata, costrette a risiedere sulle loro terre, che non potevano lasciare senza il consenso del signore.
Ma questa condizione non era diffusa nel medioevo e soprattutto non nell’alto medioevo. I tentativi di legare i contadini alla terra esistono nella storia, ma si applicano a contesti molto precisi: per esempio, ai tempi dell’imperatore Teodosio, dunque in età tardoantica e non medievale, e si ritrovano nell’Europa orientale, nel medioevo e anche nell’età moderna. Però, se guardiamo al complesso dell’Europa altomedievale, possiamo senz’altro dire che i contadini erano in maggioranza liberi. Avevano, per esempio, la possibilità di trasferirsi da un villaggio all’altro e di instaurare rapporti di lavoro con i signori che offrivano loro migliori condizioni contrattuali.
Talvolta si unisce ai servi della gleba, un ulteriore stereotipo, ancora più grottesco: lo ius primae noctis, cioè il fantomatico diritto che il signore avrebbe avuto di trascorrere la prima notte di nozze con le fanciulle del villaggio. Anche questo è naturalmente un luogo comune e nel medioevo non è mai esistito. Aggiungiamo un’osservazione finale: usare i concetti di piramide feudale e servi della gleba per spiegare la società dei secoli centrali del medioevo contribuisce a disegnare l’immagine di un periodo buio, cupo, segnato dall’immobilità delle relazioni sociali, dall’uso arbitrario della forza e dalla prepotenza dei signori.
Quali sono allora i concetti che possono aiutarci a inquadrare correttamente la società dell’epoca? Partiamo dal concetto di vassallaggio, che non sempre è spiegato bene nei manuali, e proviamo a darne una definizione. Si tratta di un giuramento di natura militare con cui il vassallo si impegna ad aiutare in guerra il signore in cambio di un beneficio vitalizio, costituito da un bene fondiario oppure da un ufficio. Analizziamo questa definizione, prestando attenzione al lessico.
Innanzitutto i protagonisti (chi?): il vassallo e il signore sono aristocratici (ci sono rarissimi casi di vassalli di condizione servile, ma diciamo che si tratta decisamente di un’eccezione). Questo aspetto deve essere sempre tenuto presente: per esempio, i contadini non erano vassalli (è questo un punto che forse non è sempre chiaro). In alcuni casi il signore può essere il sovrano (come nel caso di Carlo Magno), e in questo caso si parlerà di vassalli regi, altrimenti possono essere anche altri appartenenti alle società aristocratiche dei secoli centrali del medioevo.
Poi i termini di questo impegno, che costituisce quasi una sorta di contratto (cosa?): si tratta di un giuramento di natura militare, quindi un impegno che, almeno inizialmente, riguarda la sfera della guerra e gli obblighi militari. Il beneficio costituisce la ricompensa data dal signore per l’impegno all’aiuto militare e può consistere sia in terre, sia nei poteri su un territorio, magari anche attraverso la concessione di un ufficio (per esempio, ai tempi di Carlo Magno, la carica di conte).
È importante rilevare anche la durata del beneficio, che permane nelle disponibilità del vassallo soltanto finché in vita, per poi tornare, alla morte, nelle disponibilità del signore. Questo almeno in termini di principio, anche se per lo più il beneficio tendeva a essere trasmesso ai figli del vassallo, che rinnovavano il giuramento e l’impegno nei confronti del signore. Il beneficio viene anche chiamato feudo, sebbene l’uso di questo termine sia preferibile soprattutto dall’XI secolo, quando diviene in maniera più chiara ereditario (trasmesso quindi per diritto di padre in figlio).
Infine, le modalità (come?). Si tratta di un giuramento, che quindi ha una sua ritualità. Gli aspetti rituali erano molto importanti e servivano a sigillare la sacralità dell’impegno reciproco. Signore e vassallo si scambiavano un bacio sulla bocca (l’osculum), il vassallo metteva le mani in quelle del signore nel gesto dell’immixtio manuum, le mani intrecciate che hanno lasciato ancora oggi il gesto della preghiera. Infine, la genuflessione del vassallo di fronte al signore.
Aggiungiamo anche quando e dove. Il vassallaggio si diffonde innanzitutto nel regno dei franchi ai tempi di Carlo Magno e di lì nell’impero carolingio. Con i normanni, nel basso medioevo, giungerà anche in Inghilterra. Infine, qual è il significato del vassallaggio (perché?). Ai tempi di Carlo Magno, serviva innanzitutto al sovrano per legare a sé le aristocrazie e impiegarne la forza militare nell’esercito, che era fondato soprattutto sulla cavalleria pesante. Nel complesso, il vassallaggio ha avuto un ruolo importante per disciplinare i rapporti politici: ai sovrani per legare a sé i maggiori aristocratici, all’aristocrazia per creare le proprie clientele e le proprie reti di fedeli.
Alcuni consigli:
- innanzitutto, diffidate dei concetti di piramide feudale e servi della gleba;
- è utile ripartire dal concetto di vassallaggio e di feudo e dalla loro definizione. Gli aspetti rituali sono rappresentati nelle miniature dell’epoca, che possono costituire un repertorio di immagini utile alla lezione;
- bisogna fare attenzione a non confondere la trattazione della curtis con quella del vassallaggio e dei feudi: i due aspetti devono rimanere ben separati, perché il primo riguarda l’economia, il secondo la politica, pertanto, i rapporti tra massari e signori non hanno nulla a che vedere con le relazioni vassallatiche e le curtis non sono feudi;
- può essere utile, per spiegare la società di XI secolo, introdurre anche i concetti di signoria e poteri locali, di modo da non insistere troppo sulla connotazione feudale della società.