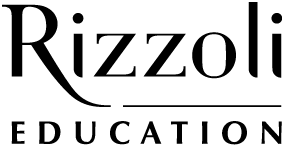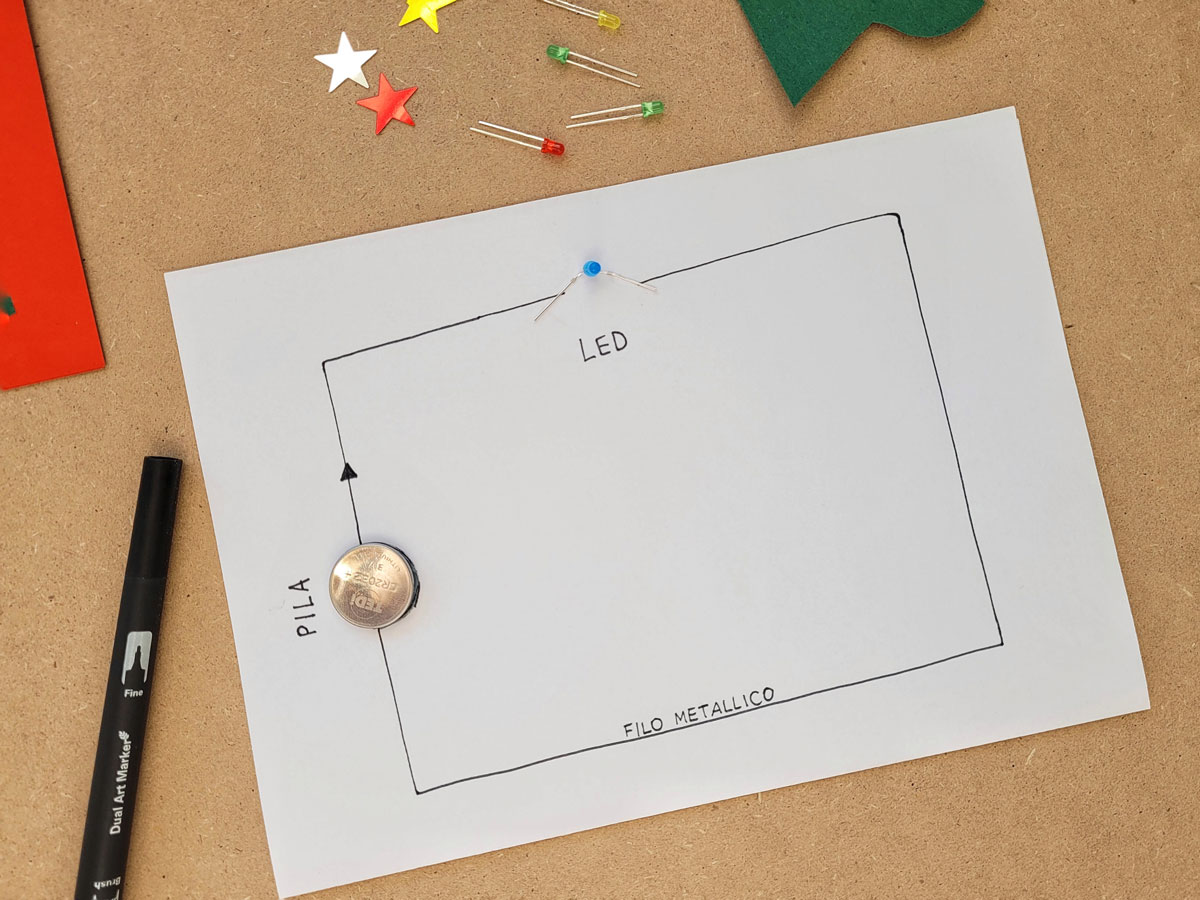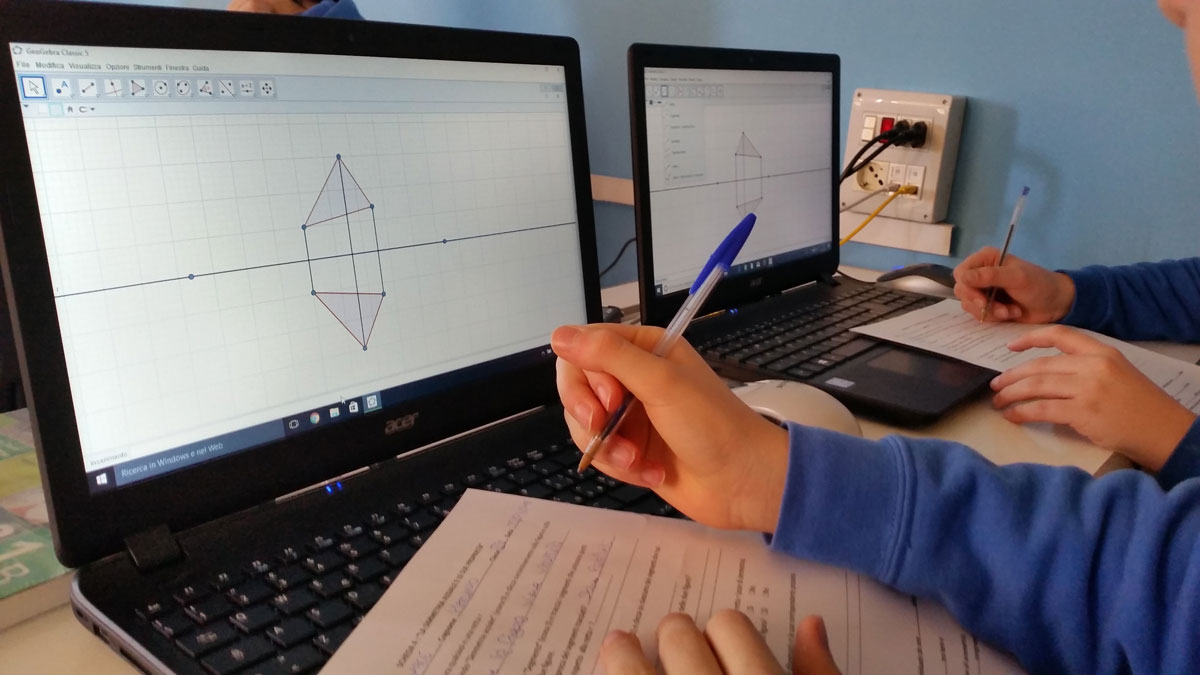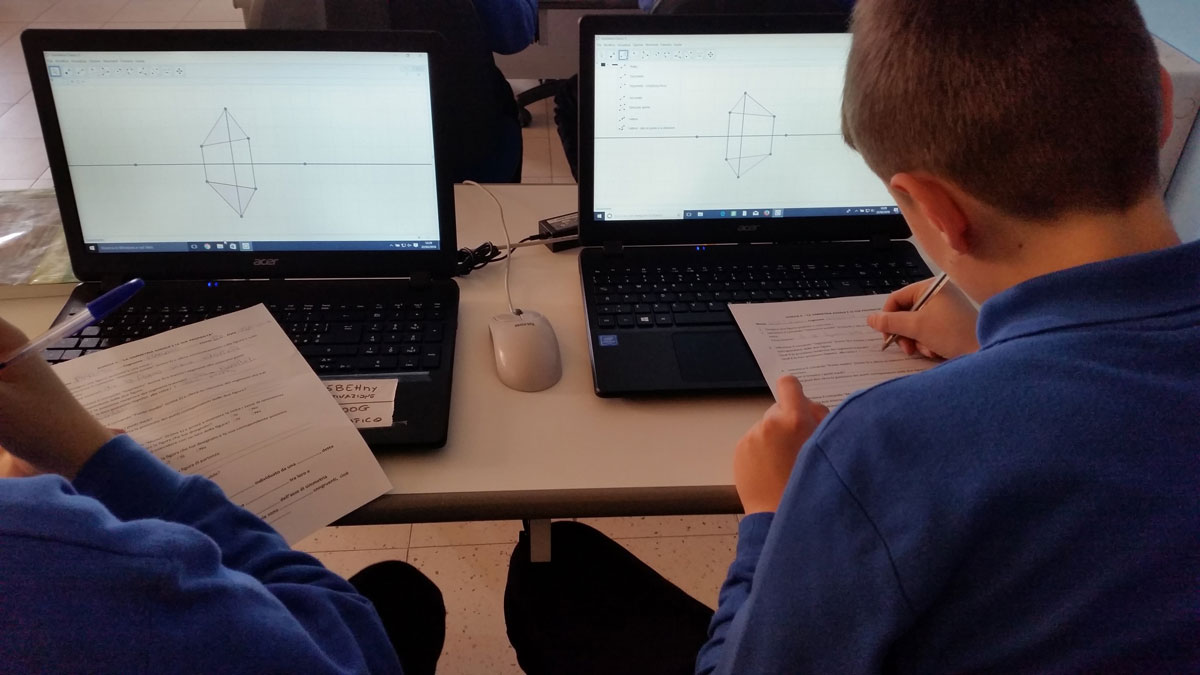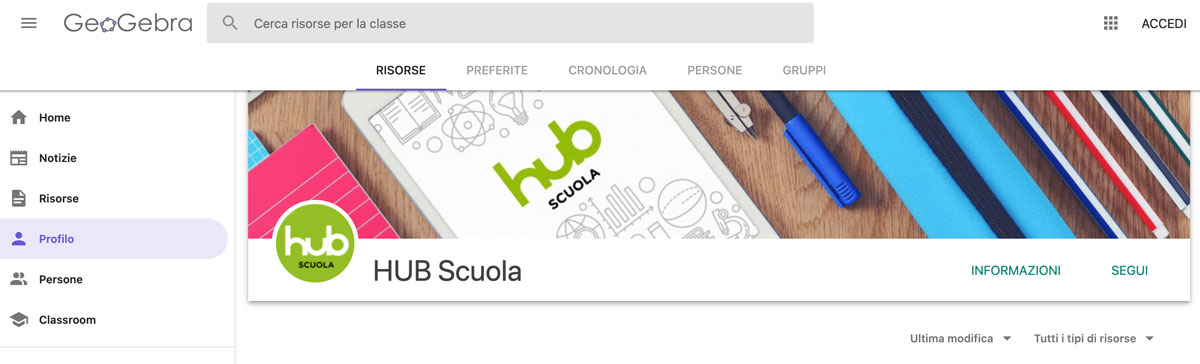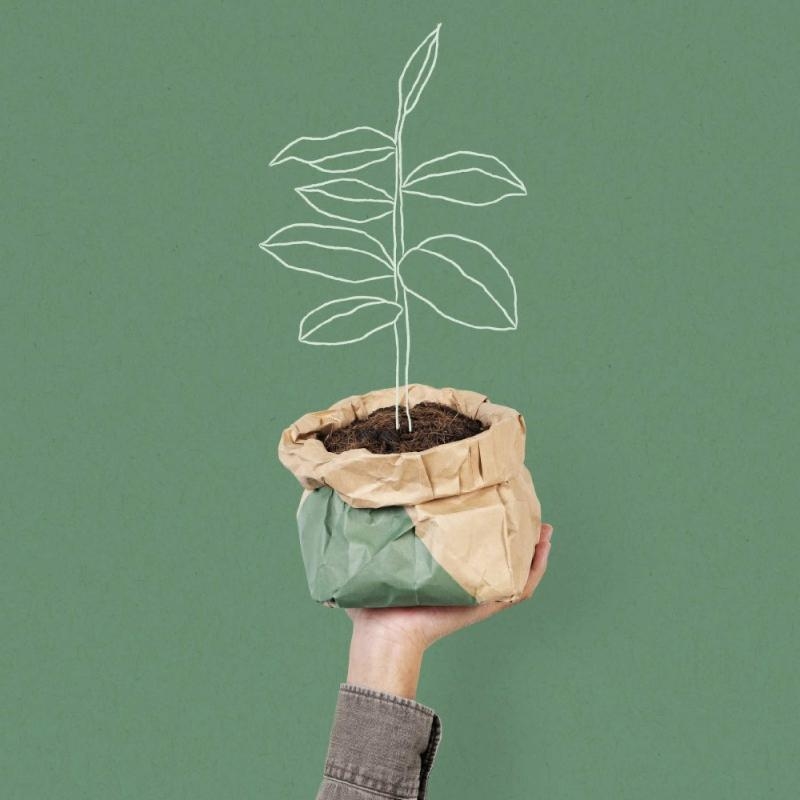Un’epoca di professionisti della guerra
Nonostante quello che si è soliti pensare della società medievale – un mondo di violenze generalizzate – in realtà il numero degli uomini abilitati a combattere si restrinse rispetto alle epoche precedenti. La guerra era affare dei milites in senso esclusivo, i quali, proprio per questa peculiarità, erano collocati al vertice della scala sociale. Dunque, i guerrieri non erano in realtà molti, anche perché l’equipaggiamento necessario aveva un costo altissimo. Grazie all’introduzione del ferro da cavallo e della staffa, infatti, le protezioni in metallo era state rinforzate e il cavaliere si trovò sempre più appesantito da attrezzature complesse.
Un potenziale bellico molto costoso
Ciò comportò un incremento dell’investimento necessario per assicurare al miles il suo potenziale bellico. E’ stato calcolato che esso, dalle armi al cavallo, valesse circa una ventina di buoi. Franco Cardini, studioso dell’età medievale, ricorda che nel 761 un “piccolo proprietario alamanno cedette tutti i suoi campi e il suo schiavo in cambio di un cavallo e di una spada” ; e che “mezzo secolo più tardi, all’inizio del regno di Ludovico il Pio, l’intero patrimonio zootecnico di una tenuta regia superava di poco, come valore globale, quello dell’armamento di un solo cavaliere”.
I cavalieri: una risposta al bisogno di sicurezza
Un cavaliere era anzitutto un “combattente a cavallo”: la sua figura risulta dominante in tutti gli eserciti dell’epoca, dagli arabi ai bizantini. In Occidente assunse un valore ulteriore. In un universo in cui la protezione era la molla che faceva scattare i meccanismi di fedeltà, il guerriero rivestiva un ruolo del tutto originale. Nacque in questo periodo, e si rafforzò intorno al Mille, il binomio miles-rusticus, ovvero la radicale opposizione fra il guerriero a cavallo e il contadino inerme, fra chi era abilitato o aveva la capacità di portare le armi e chi queste armi non avrebbe potuto toccarle mai.
Le invasioni normanne, ungare e saracene avevano dato di nuovo smalto alla funzione dei milites; poi, però, le tensioni si erano affievolite, i contatti fra la suprema autorità e la gente comune si erano allentati, ed erano emersi, come si è visto, altri soggetti, di taglia minore, sul territorio. Restava, però, l’imperativo di dare sicurezza. Quando ciò non avveniva, la popolazione si orientava verso soggetti in grado di offrire lo stesso risultato: i signori feudali, su scala locale, spinsero i propri figli cadetti, giovani e irrequieti, verso la “carriera delle armi” per incrementare il prestigio e la forza della casa.
Una lunga preparazione, anche morale, verso il “perfetto cavaliere”
Dopo un periodo di tirocinio, il giovane aspirante diveniva cavaliere nel corso di una solenne cerimonia che solo dal X secolo assunse un carattere anche religioso. Il nuovo combattente, attraverso un cerimoniale d’investitura, avendo assunto l’impegno a rispettare il codice cavalleresco, riceveva dal “padrino” l’equipaggiamento dopo che questi gli aveva assestato un ceffone, inflittogli per saggiare la capacità di controllare le offese ricevute. In questo modo, l’esistenza caotica del cavaliere corazzato veniva “normalizzata” e ricondotta ad un fenomeno funzionale alla stabilità sociale. Cominciava così un’avventura che poteva concludersi con il matrimonio con una ricca ereditiera. Ma in questo caso ci troviamo già proiettati in un’epoca, fra la metà del Mille e i primi del XIII secolo, nel corso della quale la cavalleria aveva subito uno sostanziale codificazione grazie all’elaborazione di comportamenti consolidati e ritualizzati.
Il perfetto cavaliere avrebbe dovuto mostrare coraggio e generosità; mettersi al servizio degli inermi, dei poveri, delle vedove; e poi partecipare alla lotta contro gli “infedeli”, cooperando alla Reconquista in Spagna o alla liberazione del Santo Sepolcro.
La letteratura cortese: una trasposizione culturale
La letteratura “cortese”, a partire dal XII secolo, avrebbe contribuito a stilizzare questo comportamento, nel quale la purezza di cuore si associava all’idealizzazione della figura femminile. Le chansons de geste testimoniano appunto un simile processo: la trasposizione di uno stereotipo culturale in un passato ormai remoto, e comunque non facilmente decifrabile, in cui le avventure di re Carlo, dei paladini, o di re Artù e dei cavalieri della Tavola rotonda, potevano rifulgere quali prototipi tipici delle virtù dell’ordine equestre.