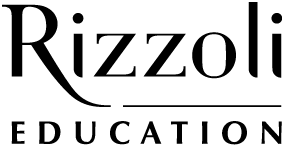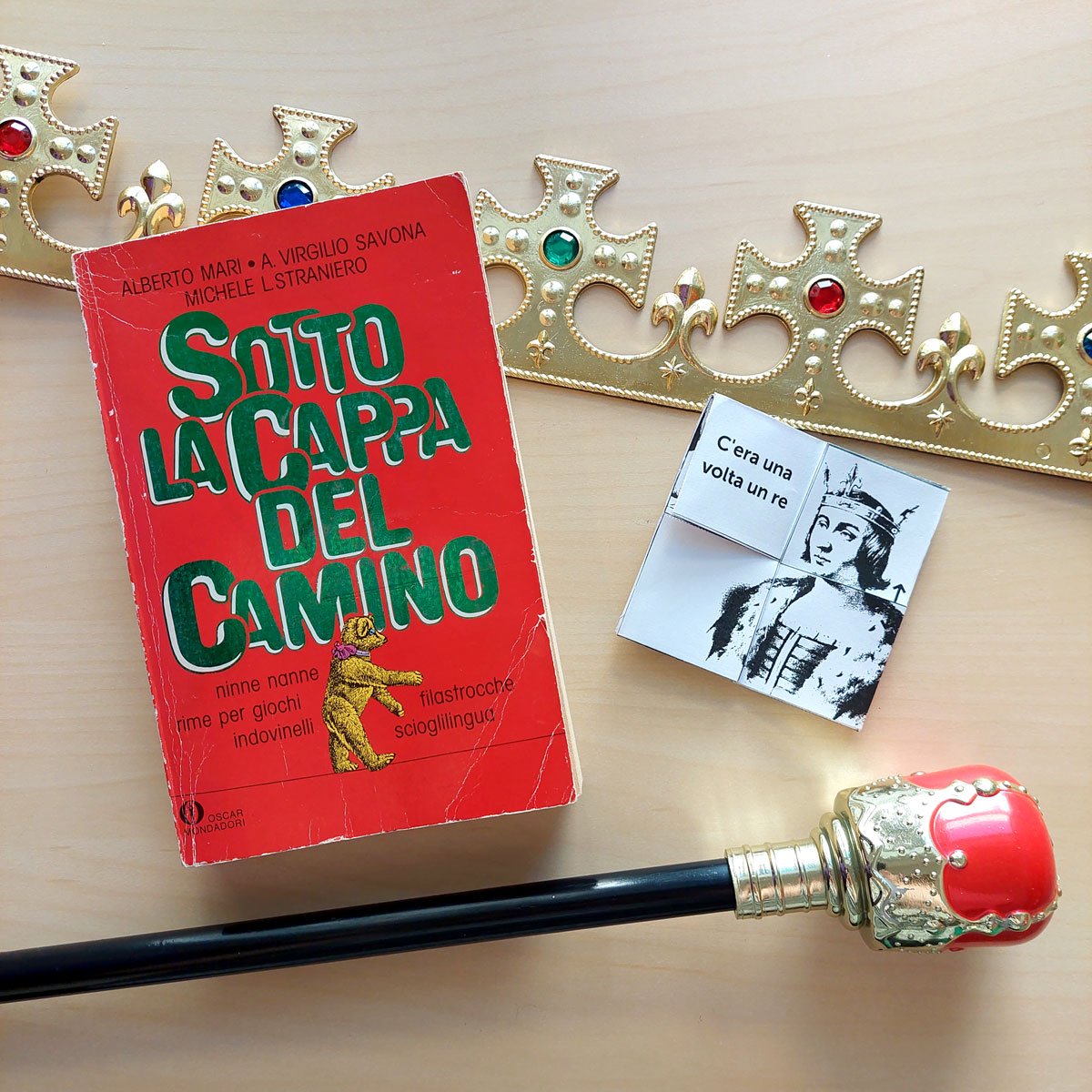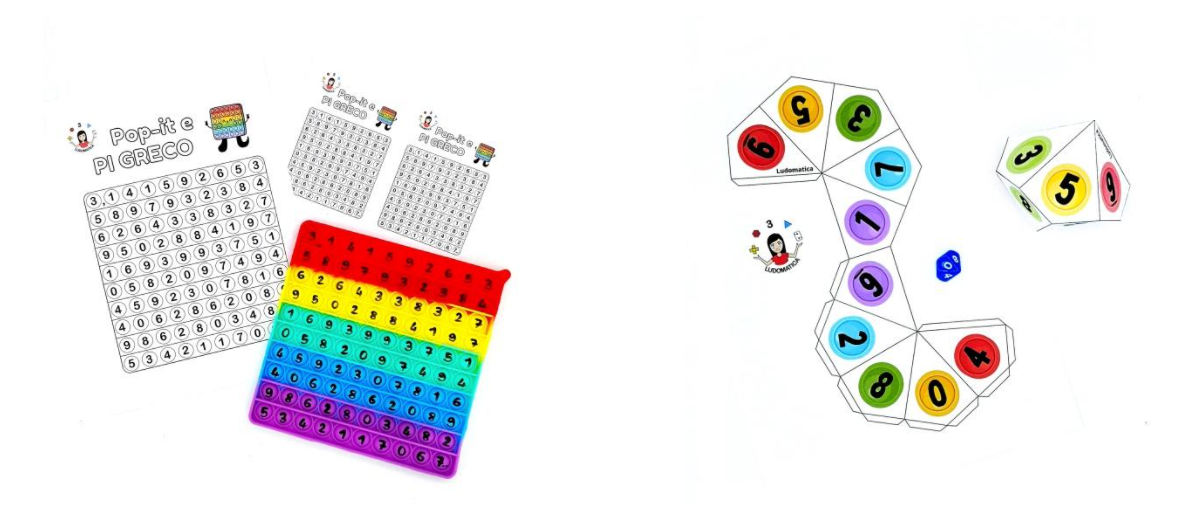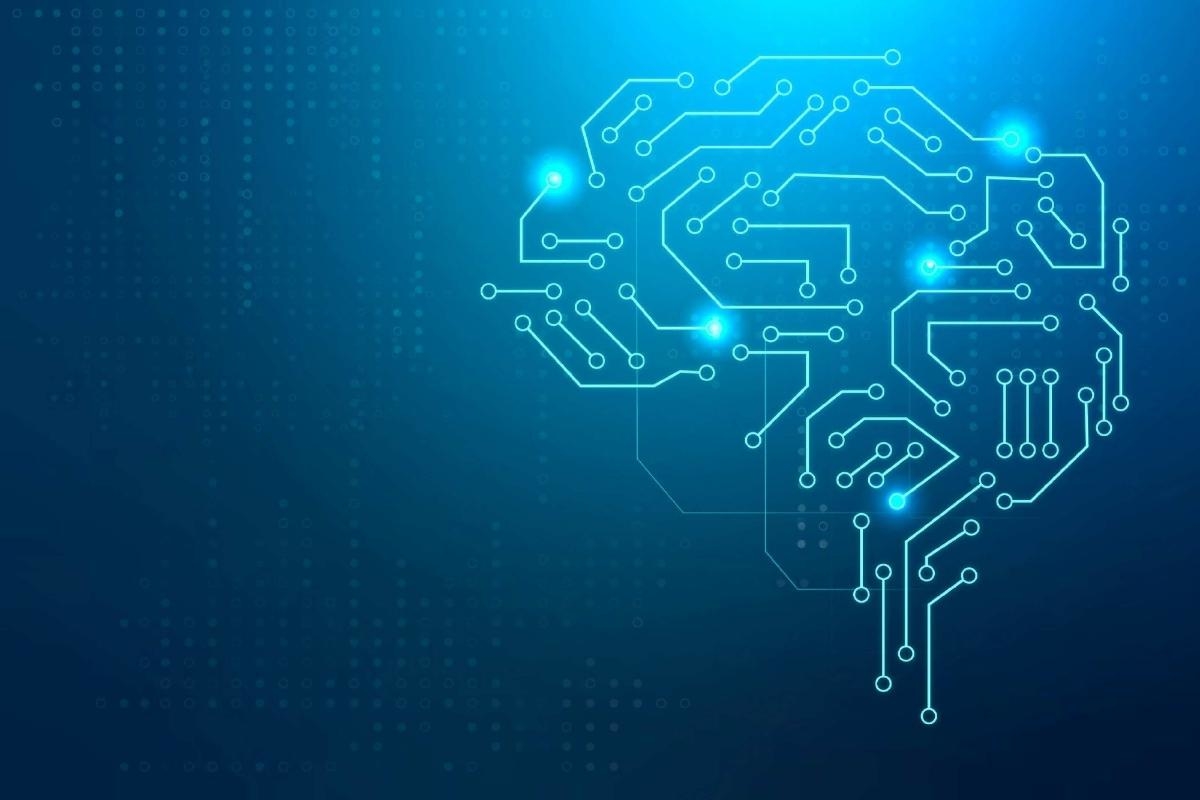Nelle discipline scolastiche, in particolare nella storia e nella letteratura, gli animali sono spesso “comparse” relegate all’ambito dell’aneddotica o del folklore: si pensi al cane Argo dell’Odissea o agli elefanti di Annibale. Eppure essi costituiscono un canale privilegiato per accostarci e per far avvicinare i nostri studenti e le nostre studentesse al mondo antico, perché si tratta di creature familiari anche a noi, nei confronti delle quali l’atteggiamento dei greci e dei romani era spesso molto simile al nostro. Il rapporto con gli animali è inoltre un tema centrale nell’educazione civica, perché rientra tra gli obiettivi dell’agenda 2030 (in particolare i goals 14 e 15 sulla vita sott’acqua e la vita sulla terra). Per comprendere a pieno le caratteristiche di una civiltà, antica o moderna, è indispensabile considerare il modo in cui essa si rapporta con gli altri esseri viventi, se li rispetta, e come li assume nel proprio immaginario. Per tutti questi motivi abbiamo inserito, nel nostro manuale Le porte della storia, una rubrica specifica dedicata ad alcuni animali che hanno assunto un significato particolarmente pregnante in differenti epoche o luoghi: a partire da questo spunto vi propongo, di seguito, un breve percorso alla scoperta del mondo greco-romano, osservato da questo particolare punto di vista.
Il cane
Plutarco, nella Vita di Temistocle, racconta che quando gli ateniesi furono costretti ad abbandonare la loro città sotto la minaccia dell’invasione persiana, nel 480 a.C., una delle cose più strazianti da vedere era la disperazione dei cani, abbandonati per l’impossibilità di metterli in salvo. Il cane di Santippo, padre di Pericle, seguì a nuoto la trireme del padrone fino a Salamina, per poi morire di fatica sulla spiaggia, là dove “ancor oggi c’è un luogo, chiamato Tumulo del Cane, ove dicono sia sepolto”. Fedele e prezioso aiutante di cacciatori e pastori, oltreché custode della casa (come dimostrano le celebri iscrizioni Cave canem, frequenti sulle soglie delle case di Pompei), il cane è spesso, nell’iconografia, simbolo di lealtà e amicizia. Eppure, nell’immaginario antico, non perde del tutto la sua natura selvatica, che lo avvicina al suo antenato lupo: la cagna è emblema di sfrontatezza femminile e nel formulario omerico i cani, insieme ai corvi, sono gli animali che divorano i cadaveri degli eroi insepolti.
Il lupo
L’ingresso in città di uno o più lupi era considerato dai romani un prodigio, un inquietante avvertimento inviato dagli dèi per segnalare la rottura della pax deorum, l’alleanza stretta tra mondo umano e divino a vantaggio della comunità, che poteva essere ripristinata solo grazie a specifici riti espiatori. Il lupo era infatti percepito come una presenza “altra” rispetto alle norme della vita civile. Questa sua connotazione negativa, che emerge anche nella tradizione favolistica antica, dipende certamente dalla minaccia che esso rappresentava per le greggi, in una società come quella greco-romana, la cui economia era largamente basata sulla pastorizia. Ma è proprio una lupa ad allattare i neonati Romolo e Remo, assumendo un ruolo determinante nella tradizione di fondazione di Roma: una lupa eccezionale, però, che si comporta “come un animale addomesticato” (Dionigi di Alicarnasso) ed è legata al dio Marte, che l’ha inviata a proteggere i suoi figli. Nella festa dei Lupercalia, celebrata il 15 febbraio a Roma, l’elemento selvaggio rappresentato dai lupi irrompe ritualmente in città: giovani seminudi, chiamati Luperci, corrono per le vie, colpendo con strisce di pelle caprina le donne che incontrano, favorendone in questo modo la fecondità. L’ordine della civiltà viene rotto temporaneamente e, col consenso dei cives, il lupo prende possesso dello spazio urbano, ma solo fino alla fine della festa.
Il leone
La prima impresa compiuta da Eracle è l’uccisione del leone di Nemea, in Argolide, un animale eccezionale, dalla pelle invulnerabile, che l’eroe strangola a mani nude e di cui indossa poi il manto come un talismano che lo proteggerà e diverrà uno dei suoi attributi più emblematici. Il leone in questione è una creatura fantastica, figlia, secondo la Teogonia di Esiodo, di altri due “mostri”, Ortro e Chimera: nella regione dell’Argolide non vi erano grandi felini, benché la loro presenza sia attestata invece sulle montagne della Grecia settentrionale. Nell’immaginario antico questo animale viene percepito come un dominatore fiero e arrogante, con tratti esotici che affascinano gli organizzatori dei crudeli giochi del circo, a Roma: Pompeo da solo ne fa sterminare 600 nei suoi memorabili ludi del 55 a.C. La caccia al leone è riservata, oltreché agli sventurati gladiatori del Colosseo, a personaggi eccezionali come Eracle, appunto, o la ninfa Cirene, eponima della città africana, che secondo il mito sopraffece l’animale con la sola forza delle braccia, destando in questo modo l’amore appassionato del dio Apollo, che la stava osservando. La percezione antica del confronto-scontro tra umani e leoni ricorda, mutatis mutandis, certe pagine di Karen Blixen, nella Mia Africa o nelle Lettere, in cui l’autrice descrive la potente emozione provata nel fronteggiare il maestoso animale. Proprio l’approccio predatorio tipico soprattutto del mondo romano, ha portato, dobbiamo ricordarlo, allo sterminio di migliaia di grandi felini, causando la completa estinzione del leone nord-africano.
L’elefante
Anche gli elefanti, come i leoni, sono stati sterminati a migliaia nei giochi romani del circo, e Plinio il Vecchio descrive il commovente comportamento di alcuni di questi animali, durante i già citati giochi organizzati da Pompeo nel 55 a.C.: “persa ogni speranza di fuggire, cercarono di attirarsi la compassione degli spettatori […] con una sorta di lamentazione, provocando tanta commozione nella folla che questa […] si alzò tutta in piedi e scagliò contro Pompeo delle maledizioni, che ben presto egli scontò”. Oltre al curioso riferimento profetico alla tragica fine di Pompeo, che sarebbe dunque dovuta alla sua crudeltà nei confronti degli innocenti pachidermi, colpisce la forte empatia che si stabilisce tra persone e animali: sono passati molti anni dalla prima volta in cui i soldati romani hanno ascoltato con terrore il barrito dei colossali elefanti che avanzavano tra le file dell’esercito di Pirro, e li hanno scambiati per buoi dalle dimensioni mostruose. La familiarità e la simpatia nei confronti di questi animali è ormai tale che lo stesso Plinio può affermare che essi sono i più vicini al genere umano per sensibilità e intelligenza e, anzi, possiedono qualità più nobili delle nostre: “onestà, saggezza, senso della giustizia, perfino un religioso rispetto per gli astri e un culto particolare per il sole e per la luna”. L’enciclopedista latino dimostra qui di applicare all’elefante quel procedimento di “antropomorfizzazione” che caratterizza anche la nostra visione del mondo animale.
Il serpente
Rispetto agli animali trattati finora, il serpente ci pone di fronte a un immaginario e a un comportamento che sono in gran parte molto lontani dalla nostra sensibilità moderna. Gli antichi, i greci in particolare, percepivano infatti il lato inquietante di questa creatura, dovuto essenzialmente al fatto che fosse privo di arti e che strisciasse sul terreno, ma ne deducevano un suo legame complesso e oscuro con la sfera divina. Sotto le spoglie del serpente infatti può nascondersi una divinità: il dio medico Asclepio, in particolare, che assume questa forma quando il suo culto viene esportato da Epidauro ad Atene, e in quell’occasione (nel 420 a.C.) è il tragediografo Sofocle a ospitare il serpente sacro nella propria casa finché non viene costruito il tempio alle pendici dell’Acropoli. Si trattava di uno dei molti rettili allevati nel santuario di Epidauro, dove essi svolgevano anche funzioni guaritrici, leccando e risanando le piaghe. Nell’immaginario comune, ma anche nella vita quotidiana, il serpente viene considerato in Grecia un custode efficacissimo, sia delle più umili dimore sia dei tesori più eccezionali, come il vello d’oro o i pomi d’oro delle Esperidi, cui fanno la guardia rettili soprannaturali, temibili e dotati della capacità di non dormire mai. Forse per il suo aspetto inquietante e il fatto che la sua tana è talvolta sotterranea, il serpente ha anche, per i greci, un rapporto col mondo dei morti, fino a simboleggiare, sulle lapidi, l’anima del defunto, cui si rendono affettuosi omaggi e libagioni, anche per placarne l’eventuale potere. È per noi più difficile comprendere il rapporto che gli antichi avevano col serpente “domestico”: l’animale, naturalmente di una specie non velenosa, veniva infatti tenuto nelle case greche, a custodia del focolare, mentre la sua immagine nei larari romani incarnava la divinità protettrice della famiglia e della casa, il genius loci. Ma non basta: pare che l’imperatore Eliogabalo (III sec. d.C.) allevasse, tra l’altro, serpenti egizi, non sappiamo se per motivi legati alla sua profonda e complessa religiosità o per un semplice capriccio.
Consigli di lettura
- Plinio il Vecchio, Storie naturali (libri VIII-XI), a cura di F. Maspero, Rizzoli 2011
- Eliano, La natura degli animali, a cura di F. Maspero, Rizzoli 1998
- Pietro Li Causi, Gli animali nel mondo antico, Il Mulino 2018
Link
Scopri l’opera
- “Le porte della storia” di Riccardo Rao e Anna Però – La Nuova Italia – Rizzoli Education, 2022 – Testo di geostoria per la scuola secondaria di secondo grado