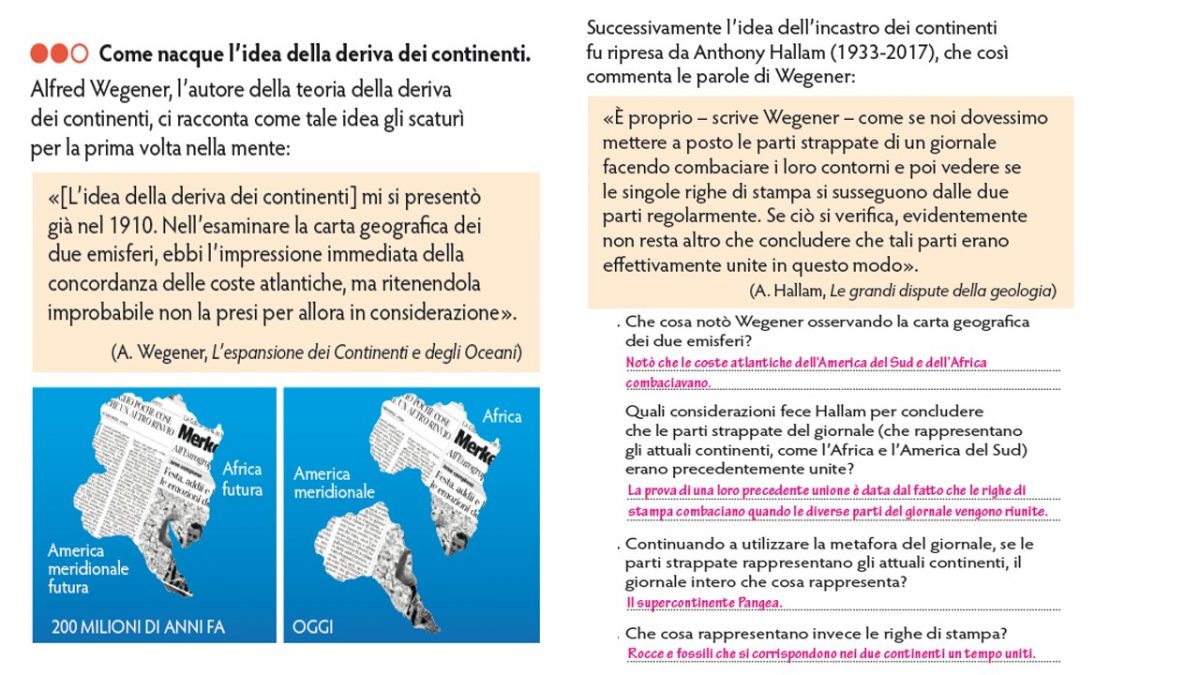Abbiamo ormai compreso come non sia da considerarsi neutro il racconto ininterrotto di profili maschili che, per anni, svolgiamo nelle classi quando insegniamo storia, letteratura, filosofia o storia dell’arte e di come, al contrario, possa essere molto condizionante a livello di percezione di sé e delle proprie capacità. Si tratta di una prospettiva che è importante, se non doveroso, correggere per il pericoloso insegnamento implicito che veicola.
Il punto è come correggere questa parzialità. La tentazione è spesso quella di cercare di integrare presenze femminili, anche a costo di andare a riscoprire personalità modeste, artiste dilettanti di scarso spessore, meritevoli solo d’averci provato – il che, soprattutto in determinati momenti storici, non è certo poca cosa – ma forse più rilevante a livello di biografia che non di professione. Così facendo, il rischio è di avallare l’idea, il bias cognitivo per usare un’espressione oggi molto usata, che la ragione per cui mancano donne è perché queste non siano di fatto in grado di creare grande arte.
Allora ha forse più senso raccontare le ragioni di queste assenze, ovvero restituire il contesto, il sistema escludente che caratterizzava il mondo dell’arte: scuole, accademie e concorsi erano di fatto chiusi alla donne, e con loro il riconoscimento professionale, un titolo senza il quale non era possibile accedere alle committenze più prestigiose e remunerative. Ma non era solo questo, prima ancora c’erano da superare le resistenze che l’ambiente (la famiglia, la società) imponeva, un condizionamento che agiva in modo più subdolo, rispetto ai divieti manifesti delle Accademie, e quindi più difficile da affrontare.
Ovunque si ripeteva che era sbagliato per una donna avere ambizioni, in tal senso anche la religione rafforzava l’insegnamento proponendo come modelli da imitare ed esempi di virtù donne (prime tra tutte Maria) modeste, ubbidienti e silenziose votate al sacrificio. L’ambizione, la determinazione, l’entusiasmo nel promuovere il proprio lavoro erano considerati pregi da ammirare in un uomo, ma pericolosi segnali di arroganza, presunzione in una donna. L’applicazione alle arti non era sconsigliata, anzi, purché rimanesse nell’ambito del dilettantismo, purché non disturbasse le persone che la donna aveva attorno in famiglia, purché non la distogliesse dalla sua unica e vera vocazione: l’accudimento e la cura.
Basterà forse ricordare che per Berthe Morisot, appartenente al gruppo Impressionista fin dalla prima esposizione, era davvero difficile fare quello che, con assoluta disinvoltura e facilità, facevano i colleghi maschi, ovvero la pittura en plein air che, non dimentichiamolo, costituiva uno dei tratti più caratteristici della ricerca formale del gruppo. Uscire da sole, gironzolare per la città durante il giorno per cercare e dipingere scorci interessanti della Parigi dell’epoca – e darsi quindi l’occasione per confrontarsi con la descrizione della luce e dell’eccitante frenesia della folla lungo i boulevard o nei tanti caffè e locali – era considerato, nella migliore delle ipotesi, altamente sconveniente.
Anche la partecipazione ai vivaci e stimolanti dibattiti sull’arte era per lei molto difficile: i ritrovi al caffè Guerbois – scelto dai colleghi come luogo informale di ritrovo, in dichiarata opposizione all’ufficialità degli spazi dell’Accademia – non erano adatti a una signora, soprattutto se priva dell’accompagnamento del marito o di un familiare, quale garanzia di rispettabilità. Eppure l’artista non si è scoraggiata, la sua determinazione, insieme alla fortuna di aver sposato un uomo illuminato le permisero di superare qualche ostacolo: settimanalmente la sua casa si apriva a ricevimenti (come facevano le signore da bene della società del tempo), che però nel suo caso erano più riunioni di lavoro, in cui discutere d’arte, valutare strategie e sedi espositive ecc…
https://www.hubscuola.it/hub_art/#/dettaglio/21685
Il caso di Morisot non è certo caso isolato. Sofonisba Anguissola, Angelika Kaufmann, Rosalba Carriera, Rosa Bonheur, per citarne solo alcune, sono esempi che singolarmente ci raccontano la ragione di una così evidente assenza femminile nel mondo dell’arte: alle donne era richiesto, e ad alcuni livelli lo è ancora oggi, un carattere di eccezionalità, sconosciuto agli uomini; le donne dovevano essere eccezionalmente dotate, eccezionalmente determinate e anche fortunate nel trovare, almeno nella prima cerchia di familiari e amici, degli alleati su cui contare…il diritto alla mediocrità era solo degli uomini a cui bastava essere sufficientemente motivati per avere accesso, senza intoppi o fatiche, a un sistema di formazione e, conseguentemente, di un riconoscimento professionale.
Negli anni, lo studio di specialisti e la ricerca d’archivio hanno permesso riscoperte importanti, basti pensare al lavoro fondamentale di Lea Vergine nel restituirci l’opera di artiste di assoluto interesse nell’ambito delle Avanguardie storiche, e al lavoro che ancora oggi musei e istituzioni conducono nell’approfondire lo studio e la promozione di artiste che per decenni sono state ignorate dal sistema dell’arte. Un caso recente è quello di Regina Cassolo Bracchi (1894-1974) scultrice attiva nelle fila del secondo Futurismo e poi, negli anni del Dopoguerra, nel MAC (Movimento Arte Concreta), che lo scorso anno ha avuto una personale alla Gamec di Bergamo in collaborazione con il Centro Pompidou che, contestualmente ospitava l’esposizione “Elle font l’abstraction”.
La ricerca di Regina Bracco veniva definita al tempo, non senza imbarazzo, un “certo cubismo domestico” nei circoli maschili dell’avanguardia italiana. Eppure sono molti i primati che oggi non esitiamo a riconoscerle, non solo in quanto prima scultrice d’Avanguardia, ma anche e soprattutto per le soluzioni formali, per l’individuazione di materiali non convenzionali, per le modalità espositive. Troviamo infatti un precoce utilizzo del plexiglas che l’artista fa giocare con la luce o la scelta di sospendere l’opera ed esplorare le sue variazione di movimento, come i ben più celebri mobile di Calder.
Tuttavia il pregiudizio nei confronti delle donne distorce la percezione del loro lavoro anche quando si tratta di contributi di notevole originalità e interesse come quello di Regina, e fa sì che vengano utilizzati aggettivi come “intimo, delicato, femminile, domestico” appunto per qualificarne le opere, ricacciandole così nell’ambito del dilettantismo. Si tratta di un pregiudizio così radicato e pervasivo da essere condizionante anche per donne che hanno una percezione lucida del proprio valore. Ne risultò condizionata Regina stessa, e la cosa non ci stupisce agendo lei in un’epoca ancora lontana da una diffusa coscienza di genere: non ebbe mai un suo studio, uno spazio da dedicare al proprio lavoro e alla propria ricerca, che interpretò e adattò, forse proprio per cercare di superare le limitazioni concrete che incontrava quotidianamente, inventando un tipo di scultura che riprendeva, nelle modalità esecutive, i procedimenti della sartoria (le sculture in fogli di alluminio venivano immaginate e pianificate con l’esecuzione di veri e propri cartamodelli tridimensionali tenuti insieme da spilli).
Pensando quindi all’insegnamento dell’arte nelle scuole, quindi, potrà essere utile intervenire su due fronti: da un lato ricostruendo il contesto limitante con cui dovevano necessariamente confrontarsi le artiste, dall’altro mostrando il lavoro di artiste di indiscusso valore, magari soffermandosi a sottolineare gli elementi contestuali che hanno consentito loro una maggiore libertà di scelta e autodeterminazione e caratteriali grazie ai quali non sono state scoraggiate da un sistema culturale e sociale a questo indirizzato.
Breve bibliografia di riferimento per approfondire
- Nochlin L., Perché non ci sono state grandi artiste? (1977)
- Vergine L., L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche, 1980
- Trasforini M.A. (a cura di), Donne d’arte. Storie e generazioni, 2006
- Trasforini M.A., Nel segno delle artiste. Donne, professioni d’arte e modernità, Bologna: Il Mulino, 2007
- AA VV, Regina Cassolo Bracco, catalogo della mostra, Gamec 2021
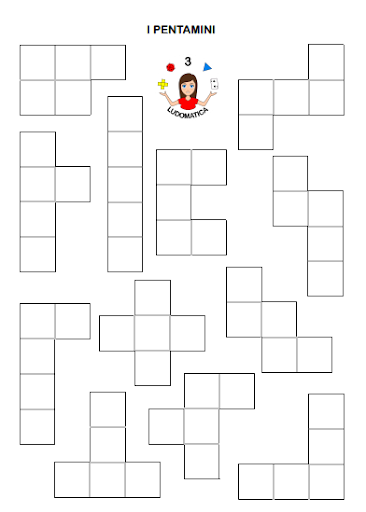
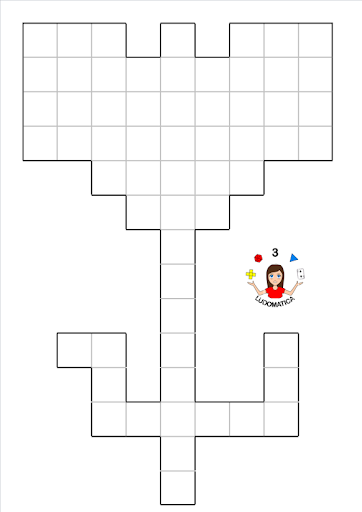
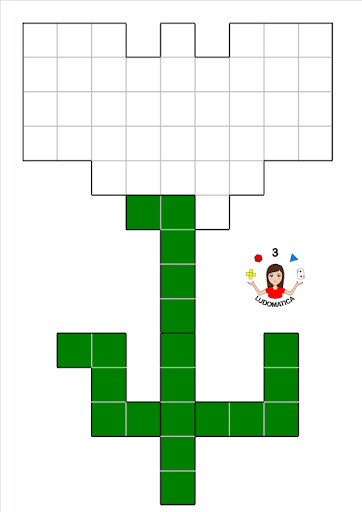
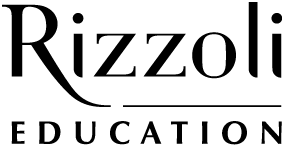

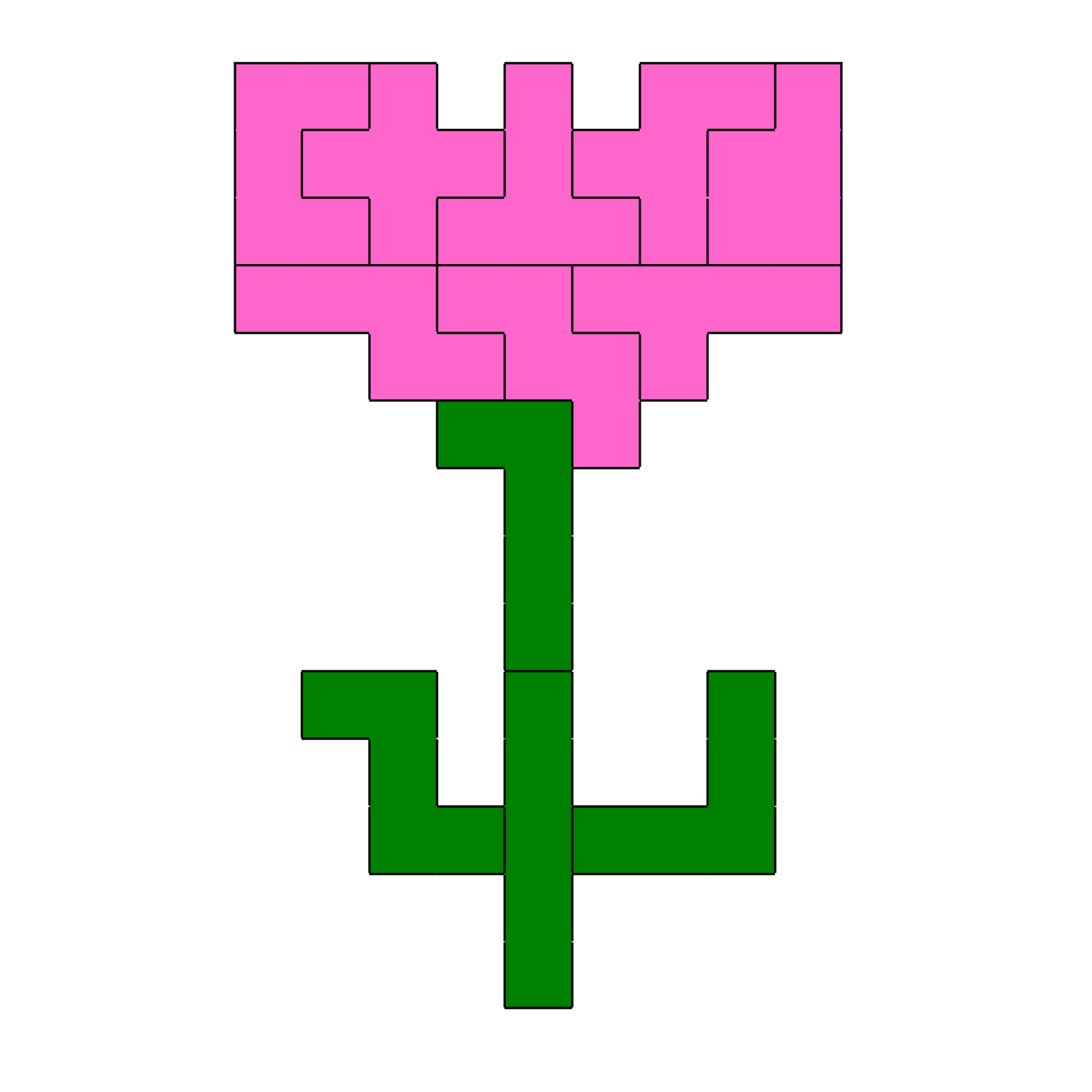

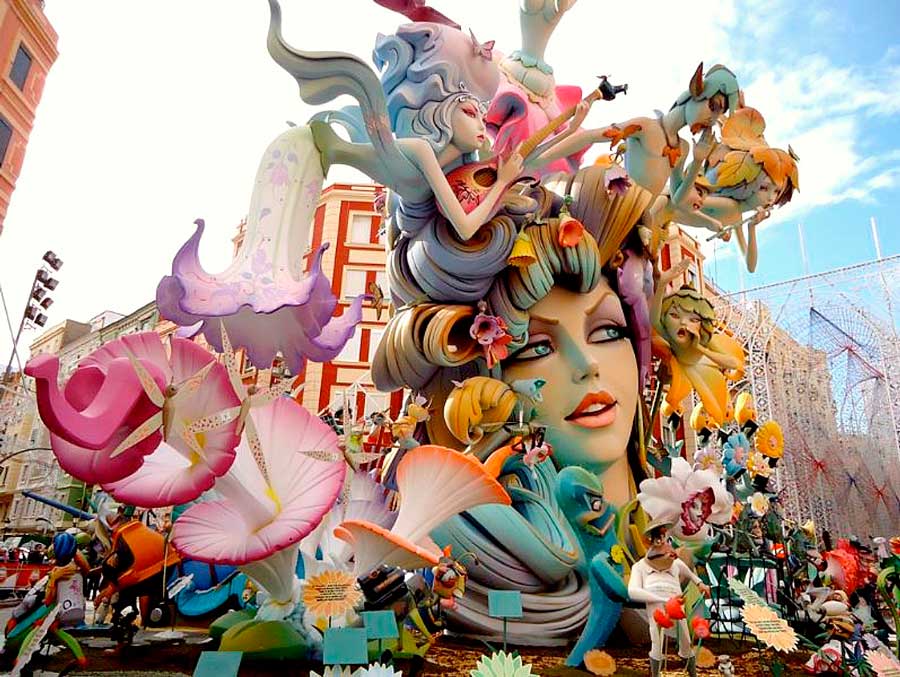





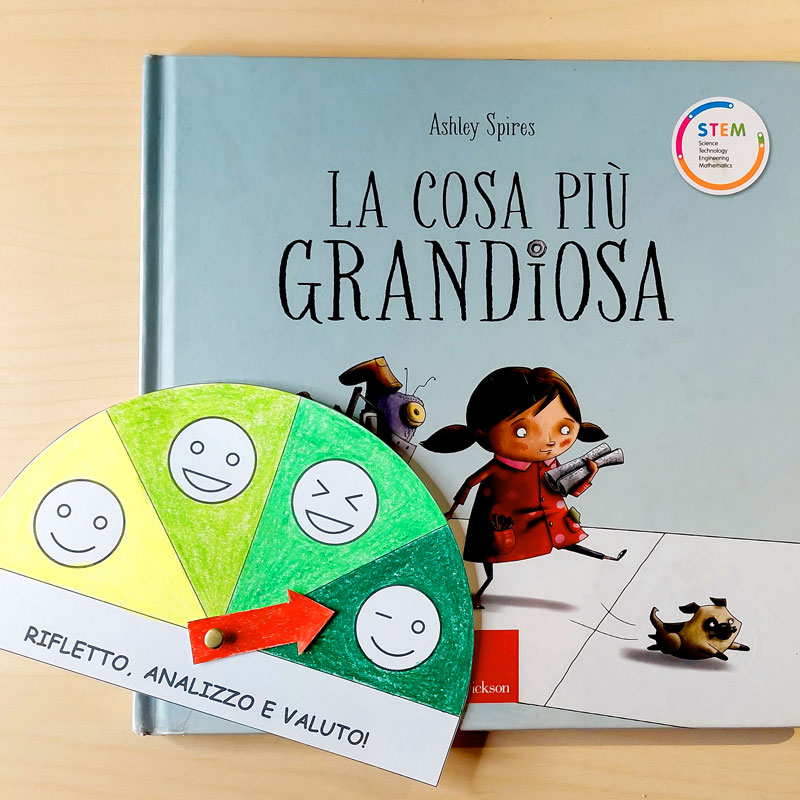
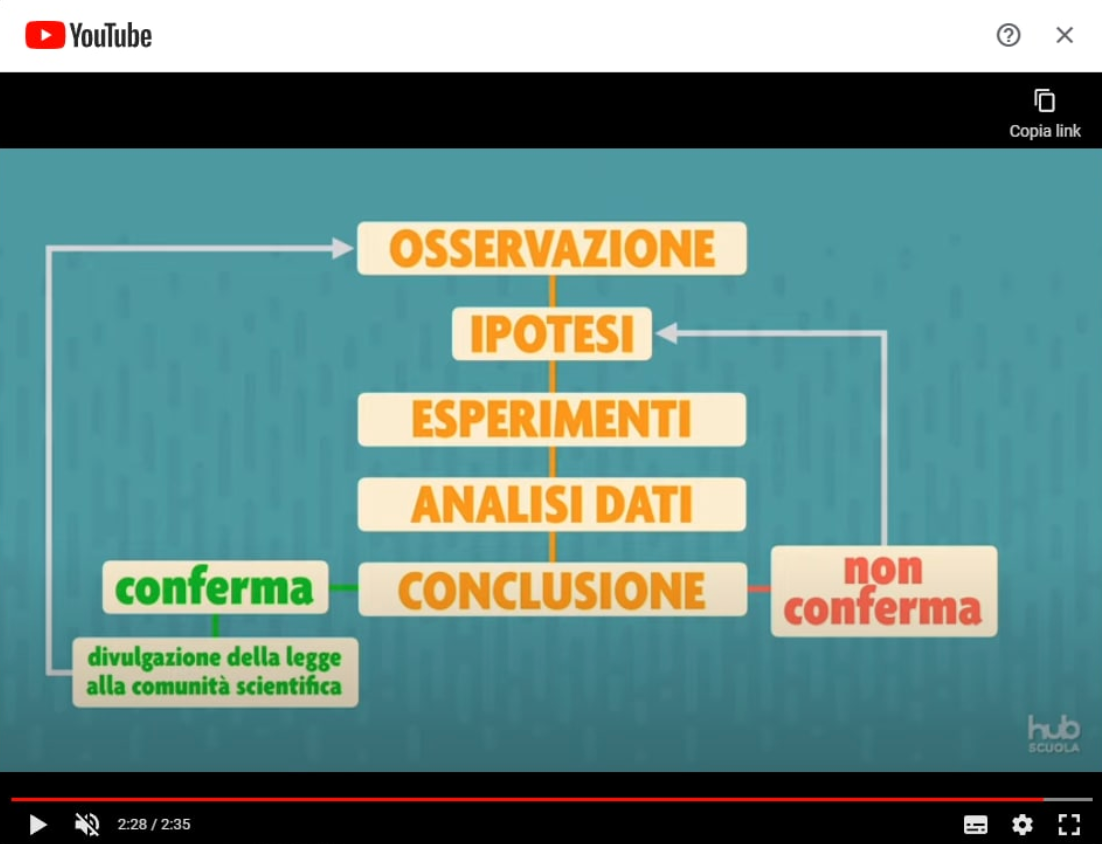

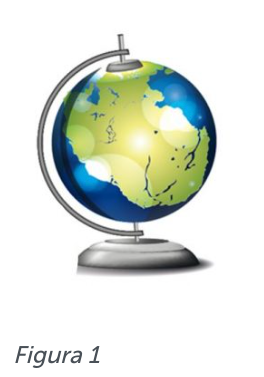
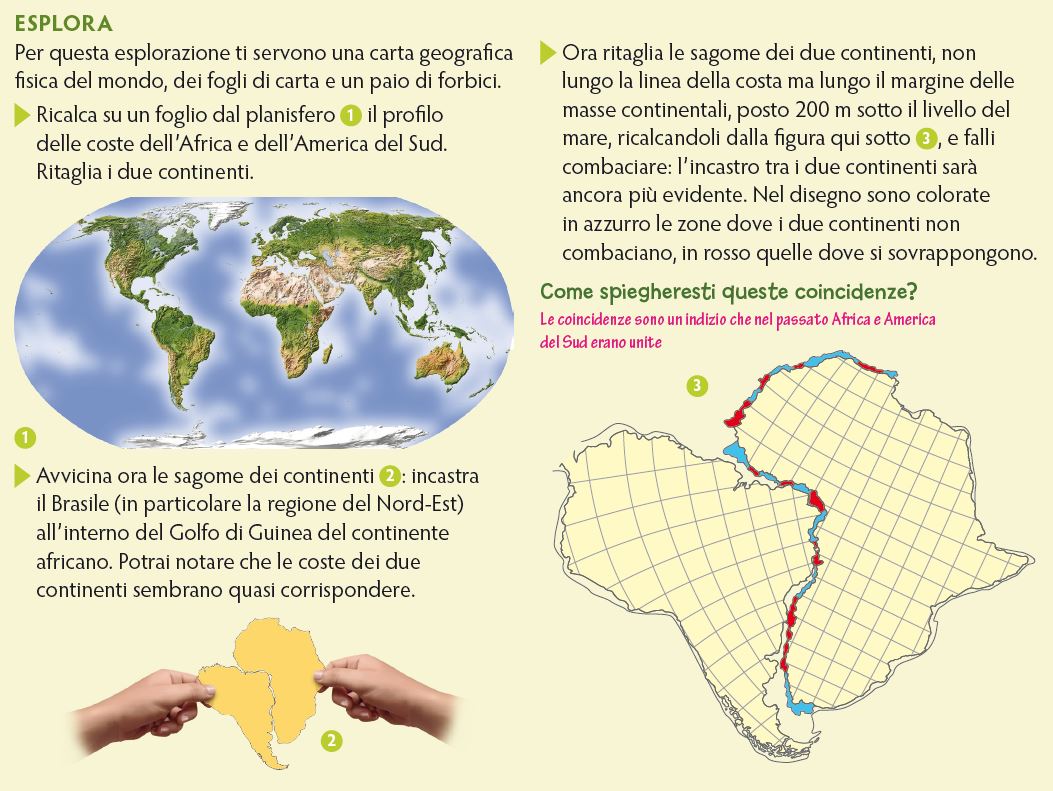
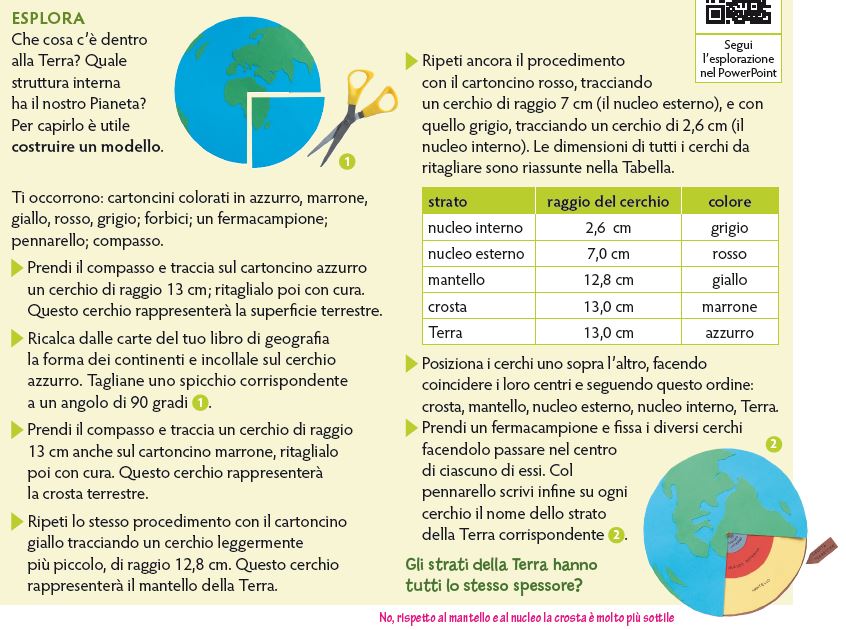 Figura 3
Figura 3