Secondaria di 2° grado Secondaria di secondo grado Economia Aziendale
Analisi e previsione delle vendite con il foglio elettronico

Il contenuto è protetto da password
Contatta la tua agenzia di zona per richiedere il codice d'accesso
Secondaria di 2° grado Secondaria di secondo grado Economia Aziendale

Il contenuto è protetto da password
Contatta la tua agenzia di zona per richiedere il codice d'accesso
I profumi hanno una particolare rilevanza in ambito storico, a causa della loro duplice natura. Da un lato infatti sono sostanze impalpabili, ma capaci di suscitare memorie ed emozioni, agendo direttamente sull’emotività umana: sono stati spesso al centro della riflessione dei pensatori del passato, e dunque sono utili indicatori per indagare la cultura dei vari popoli. D’altra parte sono anche beni materiali, inseriti in un processo di produzione e commercializzazione che permette di studiare il funzionamento delle economie antiche.
La connessione tra i profumi e la sfera del divino è sempre stata molto forte, forse proprio a causa del loro carattere effimero, intangibile, quasi spirituale. Le epifanie degli dèi sono segnalate da un profumo intenso e piacevole e alcune divinità in particolare, come Afrodite, hanno un rapporto strettissimo con i fiori e le essenze che da essi si ricavano: in una delle sue prime apparizioni nella letteratura occidentale, nel XXIII libro dell’Iliade, vediamo la dea della bellezza intenta a cospargere di olio di rosa il cadavere di Ettore, per preservarlo dalla corruzione.
Anche il nettare e l’ambrosia di cui i celesti si nutrono emanano un aroma soprannaturale, e lo stesso vale per alcuni luoghi riservati agli immortali, come le Isole dei beati, descritte per esempio da Luciano nel suo “romanzo di fantascienza” La storia vera. Inoltre il mito racconta innumerevoli vicende di fanciulli e fanciulle bellissimi e sfortunati, che dopo una tragica morte sono stati trasformati in fiori o essenze aromatiche. La vicenda più nota è forse quella di Mirra, l’eroina cui anche Vittorio Alfieri dedicò una memorabile tragedia.
La ragazza, figlia del re degli Assiri Cinira, colpita dalla vendetta di Afrodite si innamora del padre e, dopo essersi unita a lui sotto mentite spoglie, per il disonore viene tramutata nella pianta dalle cui lacrime ha origine la preziosa resina che prende il suo nome. Il legame tra profumi e divinità si riscontra anche in uno degli utilizzi principali e più antichi che le essenze avevano nel mondo antico: l’incenso in particolare veniva usato nelle cerimonie religiose e, secondo alcuni autori, come Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) e Porfirio (III-IV sec. d.C.), fu solo in un secondo momento, quando l’umanità divenne più sofisticata, ma anche più corrotta, che si cominciò a bruciare e spargere incenso e altri aromi in occasione di nozze, funerali, banchetti e gare sportive.
Le affermazioni di Plinio il Vecchio si collegano alla sua posizione moralista e critica nei confronti del profumo, visto come un lusso dispendioso proveniente dall’Oriente, che ha corrotto gli austeri costumi italici. Anche per i Greci il profumo ha un’origine orientale e “barbara”: i raffinati Lidi ne hanno insegnato l’uso ai Persiani e ai Greci d’Asia, cosicché per un Ateniese dalla vita frugale come Socrate l’eccessiva profumazione si addice a un animo servile e molle. In linea con la misoginia tipica della società greco-romana, è molto diffuso in letteratura l’assioma per cui una donna troppo profumata non può essere del tutto onesta: è emblematico in proposito il verso di Plauto (III-II sec. a.C.), divenuto proverbiale a Roma, mulier recte olet, ubi nihil olet, “una donna profuma in modo onesto quando non profuma di niente” (Mostellaria, v. 273).
Personaggi “negativi” come il golpista Catilina, il corrottissimo Verre e la regina Cleopatra (autrice forse di un trattato Kosmetikon, su belletti e profumi), sono stigmatizzati anche per la loro eccessiva familiarità con aromi ed essenze, strettamente connessi alla loro natura lasciva e pericolosa. Il lusso spropositato, di cui i profumi sono uno status symbol, è stato perciò spesso colpito anche dagli strali dei legislatori, fin dal VI secolo a.C., da parte dell’ateniese Solone, e poi a Roma, per esempio con la legge Oppia, varata nel 215 a.C., contro la quale scesero in piazza (precisamente in Campidoglio) le matrone romane, per chiedere che venisse mitigata.
L’aura negativa che accompagnava le essenze aromatiche si estendeva anche ai profumieri che le producevano e vendevano ed erano spesso di origine orientale, schiavi o liberti, considerati perciò, dai soliti autori benpensanti, persone vili, a conferma del generale discredito in cui si trovano le professioni manuali nel mondo greco-romano. Il pregiudizio di pensatori e legislatori non ostacolò però in alcun modo l’enorme successo commerciale dei profumi.
Sia ad Atene che a Roma esistevano quartieri interamente riservati alle botteghe dei profumieri, alcuni dei quali talmente noti che la loro fama è giunta fino a noi. In Grecia era celebre Plangone, una profumiera vissuta forse nel III secolo a.C., che ha dato il suo nome a un’essenza, il plangonion; nell’agorà di Atene lavoravano i profumieri anonimi cui si rivolse nel IV secolo a.C. Teofrasto, filosofo allievo di Aristotele, per ricavare informazioni tecniche da inserire nel suo trattato Sui profumi, il più antico sull’argomento.
A Roma, in età imperiale, operava invece Cosmo, citato spesso negli epigrammi di Marziale: amatissimo dalle clienti, confezionava pasticche profumate per rinfrescare l’alito e, naturalmente, un profumo battezzato col suo nome, il cosmianum. L’industria profumiera era dunque floridissima e sosteneva l’economia di intere regioni: l’India e l’Arabia felix, innanzitutto, ma anche Egitto, Giudea, le isole Cicladi e, in Italia, la Campania, che, secondo la tradizione, aveva sedotto coi suoi lussi e profumi persino l’esercito di Annibale, di stanza a Capua dopo la vittoria di Canne (216 a.C.), infiacchendolo a tal punto da determinarne la successiva disfatta.
Ogni importante profumiere, come si è visto, metteva a punto una sua personale ricetta profumata, proprio come avviene oggi con le maisons d’alta moda, ma gli ingredienti e i processi di produzione erano grosso modo analoghi: a una base di olio (d’oliva, di mandorle dolci, di sesamo) o acqua si mescolavano essenze aromatiche ricavate dalle piante (fiori, foglie, rami, radici o resine). I profumi che se ne ricavavano erano particolarmente delicati e sensibili al calore, perciò venivano conservati in recipienti di alabastro, nella cui fabbricazione erano specializzati i vasai dell’Attica e di Corinto e che sono stati infatti ritrovati in grande quantità dagli archeologi.
Tra le essenze più popolari e più antiche vi era l’olio di rosa, rhodinon, che conteneva in effetti una varietà di ingredienti, oltre ovviamente alle rose; particolarmente apprezzato era quello prodotto in Campania, a Napoli, Paestum e Pompei, dove si diceva che questi fiori avessero una fragranza speciale e sbocciassero due volte l’anno. La regione greca di Elide, patria della profumiera Plangone, era rinomata invece per il profumo all’iris, irinon; sull’isola di Cipro d’altronde, legata al culto di Afrodite e al suo mito, sono stati trovati resti di laboratori per la fabbricazione di essenze profumate risalenti al II millennio a.C.: particolarmente rilevante era qui la produzione del cipro, un’essenza che prende il nome appunto dall’isola, da cui si ricava il colorante noto come henna/henné.
Ma gli aromi più preziosi e costosi erano quelli esotici: cassia, incenso, mirra, cinnamomo e nardo nati in Arabia felix, raccolti ed esportati dalla tribù dei Sabei, che vivevano di questo commercio ottenendo guadagni ingentissimi; cinnamomo e cardamomo dell’India, che avevano affascinato già Alessandro Magno; il balsamo di Giudea, una resina profumatissima ricavata da alberi che crescevano solo in due giardini di proprietà del re. Molte di queste sostanze, per esempio l’incenso e la mirra, ma anche i diversi oli profumati ai fiori, avevano inoltre un uso farmaceutico, come testimonia il medico greco Dioscoride nel suo trattato Materia medica (I d.C.).
Si usavano poi anche in cucina, sia per aromatizzare il vino (con mirra, mele cotogne, mirto, timo, ecc.) sia per impreziosire le pietanze che facevano bella mostra di sé sulle tavole dei più ricchi durante i banchetti, cucinate da veri e propri chef dell’epoca, come il celebre Apicio (I-II d.C.). Nel suo libro di ricette L’arte culinaria il cuoco vissuto ai tempi dell’imperatore Tiberio menziona una grande quantità di spezie indispensabili per la perfetta riuscita dei piatti, che sono per lo più quelle presenti anche nei ricettari moderni: zafferano, pepe, zenzero, sesamo, menta, origano, scalogno, ecc.
Per giungere fino in Grecia e poi a Roma, molti di questi aromi dovevano essere trasportati lungo tragitti di chilometri per mare e per terra, e perciò avevano costi altissimi, che superavano, secondo Plinio il Vecchio, i 400 denari la libbra (circa 327 grammi), ovvero (con molta approssimazione) intorno ai 9000 euro di oggi. Se pensiamo al fatto che tuttora un grammo di zafferano di buona qualità costa tra i 20 e i 30 euro, la notizia di Plinio non ci stupisce più di tanto, mentre forse condividiamo in parte il suo sconcerto, riflettendo sui costi stratosferici raggiunti dai profumi esposti nelle vetrine dei negozi di via Montenapoleone a Milano, o via del Corso a Roma, corrispondenti odierni delle botteghe di Cosmo e dei suoi colleghi, nel Vicus Tuscus o nel Vicus Unguentarius.
Allora come oggi, però, al profumo si associavano una serie di significati emotivi, sociali, culturali, che valevano di certo la spesa, almeno per chi se lo poteva (e se lo può) permettere.
Consigli di lettura:
La memoria dell’Olocausto si sviluppa ovviamente nello stato d’Israele prima che altrove, dal dopoguerra. Le ferite aperte nel corpo della giovane nazione sono profonde e sanguinanti. Alla fine degli anni Cinquanta, il governo israeliano stabilizza Yom HaShoah, la giornata del ricordo, il 27° giorno di Nissan, data mobile fra aprile e maggio. Si tratta, però, di una dinamica memoriale ancora tutta interna alle comunità ebraiche, come del resto conferma la scelta della giornata secondo il calendario tradizionale.
Bisogna attendere l’ultimo decennio del XX secolo perché molti paesi si dotino di una memoria “fissa” della Shoah. In generale, nei primi lustri post-bellici prevale piuttosto la rimozione del tema: basti pensare al lungo tempo impiegato da Se questo è un uomo di Primo Levi per diventare un successo editoriale.
Gli Stati Uniti di Jimmy Carter dal 1978 per primi hanno iniziato un percorso che avrebbe condotto nel 1993 all’inaugurazione di un imponente museo/memoriale nazionale dell’Olocausto. L’attenzione riservata ai diritti umani sotto l’amministrazione Carter (1977-1980), nonché la conclusione degli accordi di pace di Camp David fra Israele ed Egitto (1978), sono stati supportati da un forte recupero culturale dell’esperienza drammatica dello sterminio degli ebrei in Europa. Lo testimonia, fra l’altro, la miniserie televisiva Holocaust, programmata proprio nel ‘78 dalla rete NBC e poi tradotta e replicata da altre emittenti a livello mondiale.
Altri paesi hanno poi sviluppato politiche analoghe: la Francia ha fissato la data del ricordo nel 1993, utilizzando una memoria “interna” (il 16 luglio, anniversario del rastrellamento del Velodromo d’Inverno nel 1942); la Germania nel 1996 ha scelto invece la liberazione di Auschwitz (27 gennaio), e così hanno fatto la Gran Bretagna e l’Italia nel 2000.
L’Italia ha scelto il 27 gennaio dopo una discussione nel corso della quale è stata scartato il giorno del rastrellamento del ghetto di Roma (16 ottobre 1943). In un primo momento, si è cercato di “nazionalizzare” il ricordo dell’Olocausto, collegandolo ad un evento accaduto nel proprio territorio; dagli inizi del XXI secolo si è invece imposta una data comune, il 27 gennaio, suggellata dalle Nazioni Unite nel 2005.
L’aspetto più significativo è rappresentato proprio dall’assunzione del 27 gennaio a data simbolo per l’intera Europa. Diversamente da quasi tutti i paesi del mondo, l’Unione si ritrova accomunata non dal ricordo di una vittoria, ma dalla ripulsa dell’antisemitismo, dal quale tutti i popoli del vecchio continente sono stati contagiati, in una fase o nell’altra della loro storia. Si celebra una sconfitta comune, quindi, in nome di un “patriottismo dell’Umanità”. E’ una novità assoluta e importante nel panorama delle diverse “memorie collettive” che animano (e hanno animato) il pianeta – in genere nazionaliste e molto etnocentriche -, della quale dovremmo tutti essere orgogliosi.
Una notte tra le pagine di Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita.
Ogni anno intorno al 23 febbraio, Reggionarra entra nelle case con la Notte dei Racconti, proponendo, a ogni edizione, un tema insieme a una bibliografia e invitando a leggere, narrare ed ascoltare storie tutti insieme, alla stessa ora. Possono aderire scuole, biblioteche, soggetti pubblici e privati, in Italia, in Europa e nel mondo intero.
Per costruire un racconto collettivo della serata anche sui social media, ogni partecipante può condividere le immagini della propria Notte dei Racconti con #reggionarra.
https://www.reggionarra.it/
Ogni anno in Italia vengono assegnati numerosi premi letterari, e molti di questi sono dedicati ai più giovani. In questa pagina abbiamo raccolto alcuni dei romanzi vincitori dei principali Premi assegnati nel 2022, romanzi che sono destinati a una fascia d’età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Esplora la sezione per scoprire gli autori e le opere premiate, le motivazioni della giuria e gli incipit dei romanzi.
Per ulteriori segnalazioni, vi invitiamo a scriverci all’indirizzo email leoperedirosettazordan@gmail.com.
Narrativa 11/14
Quattro sorelle. Enid
Malika Ferdjoukh, traduzione di Chiara Carminati, Pension Lepic
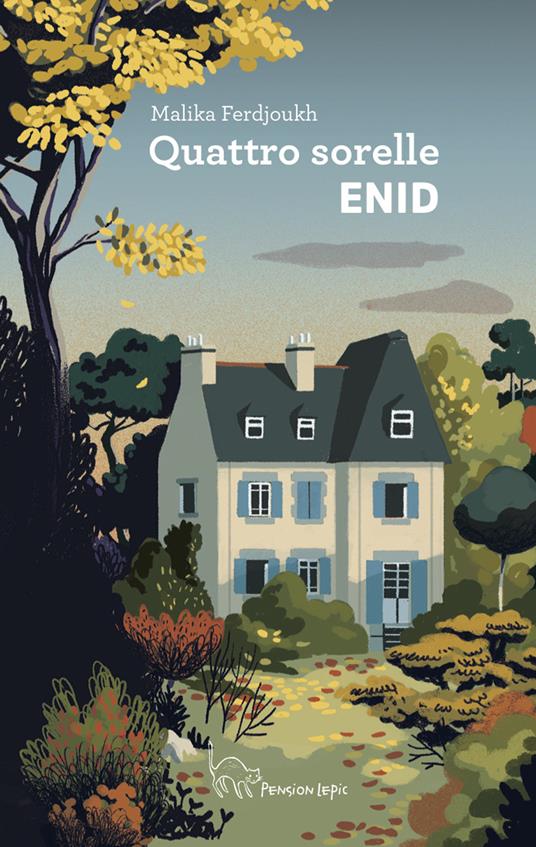 Motivazione della giuria: Pension Lepic ha portato in Italia e ai giovanissimi lettori, coetanei delle protagoniste, un vero romanzo; un romanzo familiare capace di affrontare grandi temi con vivacità e leggerezza consapevole, con grazia e fine attenzione nel guardare ai personaggi e alle loro vicende. Vicende minute e vicende grandi, svolte con un andamento pienamente narrativo, vivace e appassionante.
Motivazione della giuria: Pension Lepic ha portato in Italia e ai giovanissimi lettori, coetanei delle protagoniste, un vero romanzo; un romanzo familiare capace di affrontare grandi temi con vivacità e leggerezza consapevole, con grazia e fine attenzione nel guardare ai personaggi e alle loro vicende. Vicende minute e vicende grandi, svolte con un andamento pienamente narrativo, vivace e appassionante.
Enid ci conduce dentro al sentire delle sorelle Verdelaine e ci svela un’intimità profonda che genera empatia ed emoziona il lettore. Lo fa, inoltre, senza tralasciare momenti avventurosi e quel ritmo spensierato dello scorrere naturale degli eventi che ha desiderio di futuro. Un insieme di elementi compositivi e stilistici essenziali per appassionare i ragazzi.
La scrittura di Malika Ferdjoukh è precisa, intensa, divertente; ma è soprattutto la ricchezza di parole ad ammaliare il lettore. Una minuzia narrativa cesellata con grande maestria, da artigiana della parola, che la traduzione di Chiara Carminati ha saputo restituire con grande sapienza.
Categoria 11+
Giuditta e l’orecchio del diavolo
Francesco D’Adamo, Giunti Editore
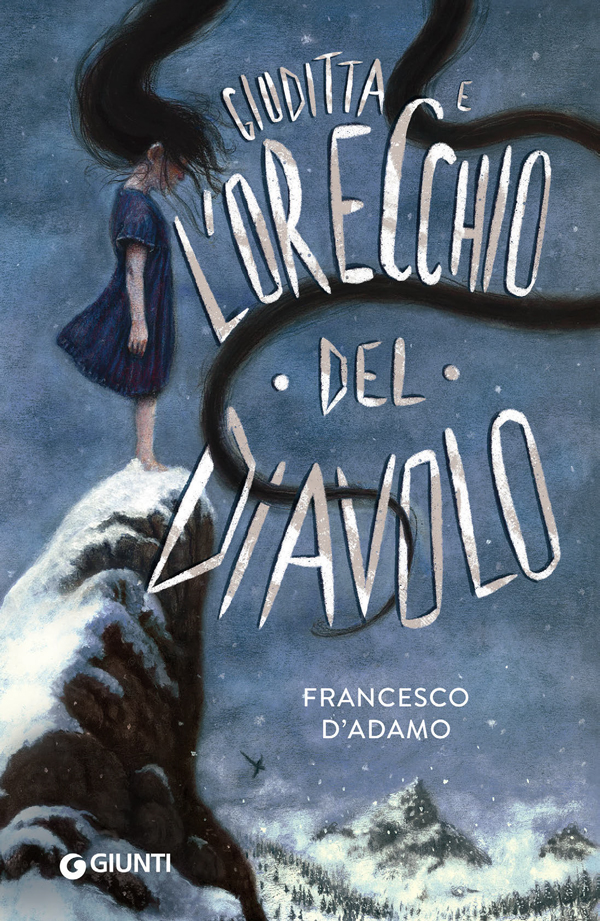 Motivazione della giuria: Francesco D’Adamo orchestra con sensibilità una storia ambientata negli anni della lotta per la liberazione dal nazifascismo, esplora la memoria e la complessità di un passaggio fondante della nostra democrazia facendo emergere dalla pagina gli odori e i rumori della montagna, il freddo delle case e le relazioni tra i protagonisti.
Motivazione della giuria: Francesco D’Adamo orchestra con sensibilità una storia ambientata negli anni della lotta per la liberazione dal nazifascismo, esplora la memoria e la complessità di un passaggio fondante della nostra democrazia facendo emergere dalla pagina gli odori e i rumori della montagna, il freddo delle case e le relazioni tra i protagonisti.
Miglior libro 9/12 anni
Il segreto
Nadia Terranova e Mara Cerri, Mondadori
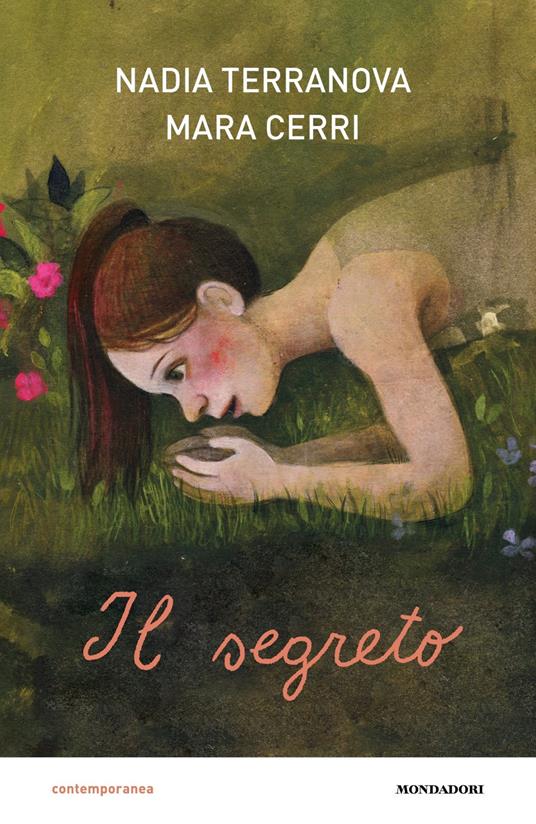 Motivazione della giuria: Per un’opera completa in cui testo e illustrazioni si mantengono linguaggi distinti ma capaci di fondersi felicemente, restituendo al lettore le atmosfere della storia e la sensazione di spaesamento e inadeguatezza della protagonista, alle prese con le difficoltà dell’adolescenza. Per la forza e contemporaneamente la delicatezza con cui vengono ritratti i personaggi che si muovono tra le pagine, intensi e affascinanti. Per una narrazione in equilibrio tra reale e fantastico, in una sospensione avvolgente, tanto malinconica quanto festosa.
Motivazione della giuria: Per un’opera completa in cui testo e illustrazioni si mantengono linguaggi distinti ma capaci di fondersi felicemente, restituendo al lettore le atmosfere della storia e la sensazione di spaesamento e inadeguatezza della protagonista, alle prese con le difficoltà dell’adolescenza. Per la forza e contemporaneamente la delicatezza con cui vengono ritratti i personaggi che si muovono tra le pagine, intensi e affascinanti. Per una narrazione in equilibrio tra reale e fantastico, in una sospensione avvolgente, tanto malinconica quanto festosa.
Miglior libro oltre i 12 anni
Tutto daccapo
A-Dziko Simba Gegele, traduzione di Raffaella Belletti, Atmosphere Libri
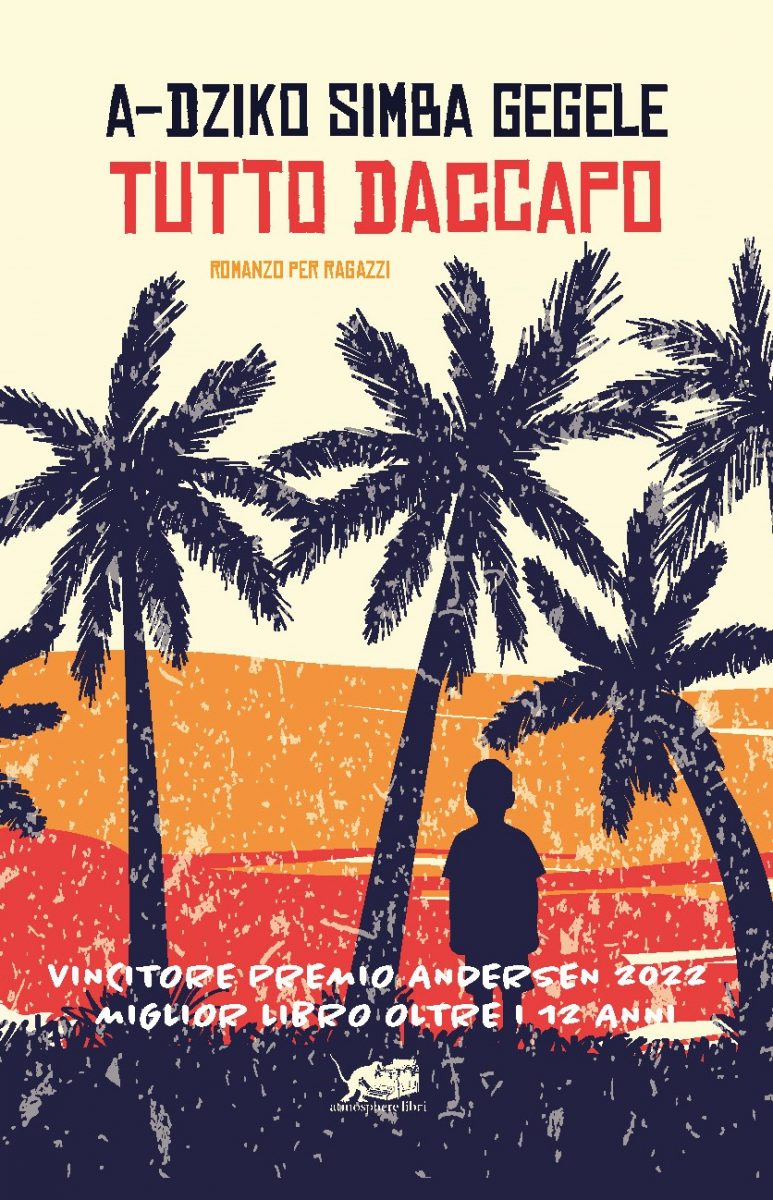 Motivazione della giuria: Per la capacità, attraverso una scrittura di pieno impatto, di far risuonare la voce fresca e autentica di un adolescente alle prese con le difficoltà dell’età, senza minimizzarle. Per la costruzione di una rete di affetti spigolosa e al tempo stesso accudente, in cui non è facile emergere e far prevalere il proprio punto di vista. Per le ambientazioni affascinanti, tra salite e discese di un’isola percorsa in lungo e in largo in bicicletta, trovando lo spazio per essere se stessi, anche solo per un minuto.
Motivazione della giuria: Per la capacità, attraverso una scrittura di pieno impatto, di far risuonare la voce fresca e autentica di un adolescente alle prese con le difficoltà dell’età, senza minimizzarle. Per la costruzione di una rete di affetti spigolosa e al tempo stesso accudente, in cui non è facile emergere e far prevalere il proprio punto di vista. Per le ambientazioni affascinanti, tra salite e discese di un’isola percorsa in lungo e in largo in bicicletta, trovando lo spazio per essere se stessi, anche solo per un minuto.
Sezione scuola secondaria di primo grado
Bianco
Laura Bonalumi, Il Battello a vapore editore
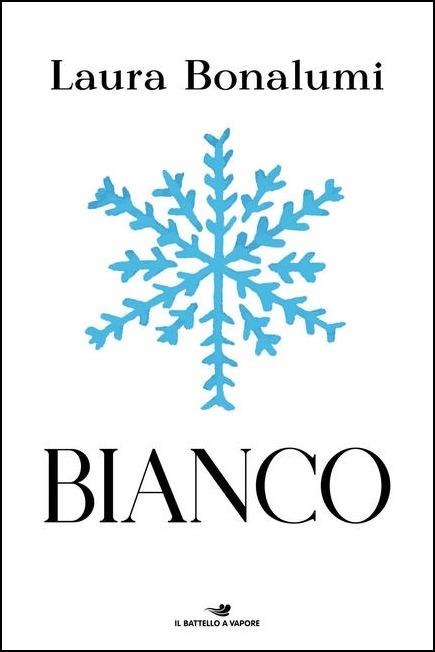 La neve non smette di cadere: dopo un mese, la meraviglia iniziale lascia il posto al terrore e alla morte. La città si trasforma in un deserto freddo, affamato, sofferente, disperato, specchio delle azioni dell’uomo. Sette persone si rifugiano in una chiesa, ciascuno ha lasciato sepolto nella neve qualcosa di prezioso, tutte hanno la stessa speranza di salvezza. Le parole eterne dei libri che legge Isabella, la voce narrante, sembrano essere l’unica ancora che li lega alla vita. Un thriller serrato, potente, disarmante, un romanzo di formazione profetico e spirituale, alla ricerca di una divinità perduta, e metafora della condizione umana in cui riscoprire il valore del prendersi cura di sé e degli altri.
La neve non smette di cadere: dopo un mese, la meraviglia iniziale lascia il posto al terrore e alla morte. La città si trasforma in un deserto freddo, affamato, sofferente, disperato, specchio delle azioni dell’uomo. Sette persone si rifugiano in una chiesa, ciascuno ha lasciato sepolto nella neve qualcosa di prezioso, tutte hanno la stessa speranza di salvezza. Le parole eterne dei libri che legge Isabella, la voce narrante, sembrano essere l’unica ancora che li lega alla vita. Un thriller serrato, potente, disarmante, un romanzo di formazione profetico e spirituale, alla ricerca di una divinità perduta, e metafora della condizione umana in cui riscoprire il valore del prendersi cura di sé e degli altri.
Questa notte non torno
Antonella Sbuelz, Feltrinelli
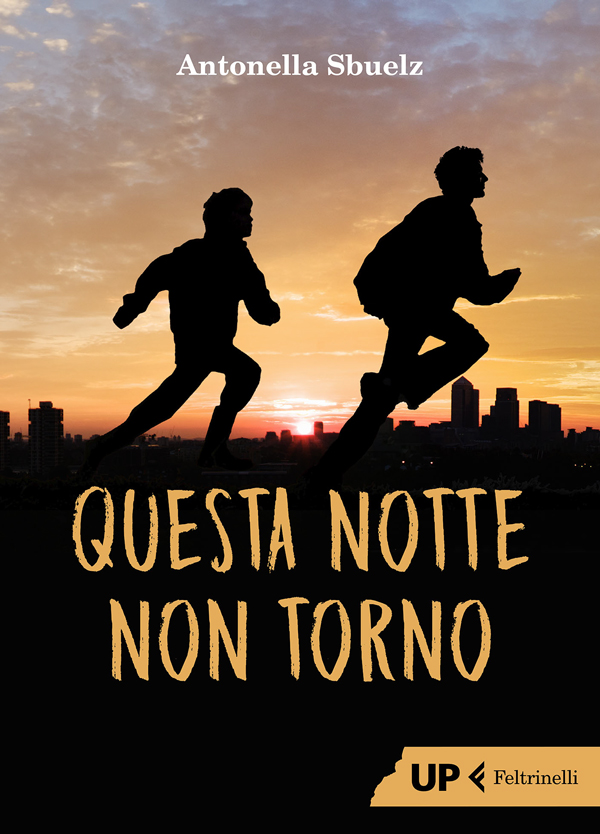 Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di casa e Aziz, dopo il lungo viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e affamato. Mentre Mattia gli dà da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio segreto nei sotterranei di una scuola, Aziz gli racconta la sua storia. Nella notte, però, Mattia si accorge che il ragazzino afghano scotta e ha la febbre alta. Cercando di aiutarlo, Mattia scopre la vera identità di Aziz, che non è affatto chi sembra. Un finale inatteso per una storia che alterna ai colpi di scena la scoperta più emozionante: quella dell’amicizia, dell’amore, dell’umanità.
Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di casa e Aziz, dopo il lungo viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e affamato. Mentre Mattia gli dà da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio segreto nei sotterranei di una scuola, Aziz gli racconta la sua storia. Nella notte, però, Mattia si accorge che il ragazzino afghano scotta e ha la febbre alta. Cercando di aiutarlo, Mattia scopre la vera identità di Aziz, che non è affatto chi sembra. Un finale inatteso per una storia che alterna ai colpi di scena la scoperta più emozionante: quella dell’amicizia, dell’amore, dell’umanità.
Sezione ragazzi
Senza una buona ragione
Benedetta Bonfiglioli, Pelledoca
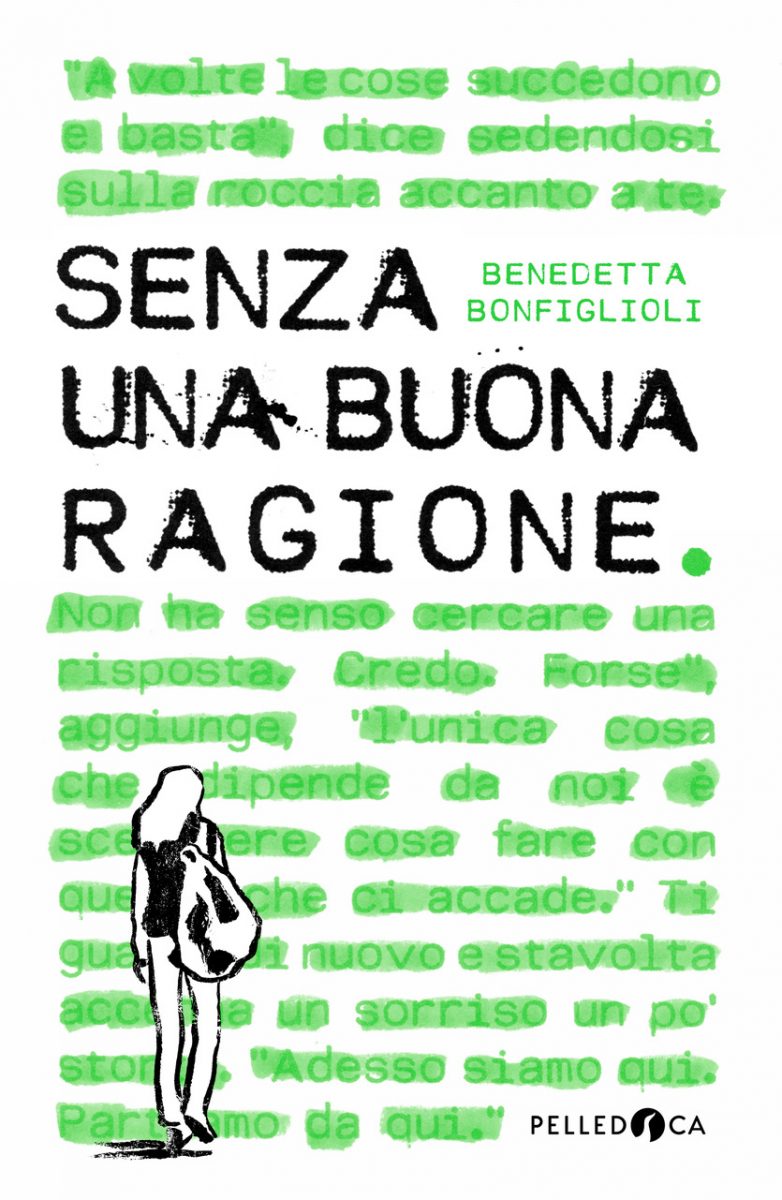 Motivazione della giuria: Per una scrittura ficcante e tagliente, che nulla tace nel raccontare una vicenda dolorosa ma vera, in cui dinamiche e conseguenze del bullismo vanno a incidere sul percorso di autodeterminazione di una adolescente. Per la capacità di evitare didascalismi, mantenendo lucida aderenza alla realtà nel raccontare le difficoltà del crescere e di intessere relazioni, anche e soprattutto in un contesto crudele. Per un romanzo che non lascia nulla al caso e tiene col fiato sospeso, riuscendo a sorprendere il lettore di fronte all’insensatezza di alcune azioni.
Motivazione della giuria: Per una scrittura ficcante e tagliente, che nulla tace nel raccontare una vicenda dolorosa ma vera, in cui dinamiche e conseguenze del bullismo vanno a incidere sul percorso di autodeterminazione di una adolescente. Per la capacità di evitare didascalismi, mantenendo lucida aderenza alla realtà nel raccontare le difficoltà del crescere e di intessere relazioni, anche e soprattutto in un contesto crudele. Per un romanzo che non lascia nulla al caso e tiene col fiato sospeso, riuscendo a sorprendere il lettore di fronte all’insensatezza di alcune azioni.
Narrativa adolescenza
Città d’argento
Marco Erba, Rizzoli
 A Srebrenica, nel 1995, viene scritta una delle pagine più nere della storia europea degli ultimi settant’anni. Ma Greta non ne sa quasi nulla: lei, nata a Milano, è concentrata sulla scuola e sulla sua passione, il nuoto. Non è mai stata in Bosnia, anche se metà della sua famiglia viene da lì. Non sa nulla dell’infanzia di suo padre Edin, delle intere giornate che ha passato, lui musulmano, a giocare nei boschi con Goran, l’inseparabile amico serbo. Dal passato, però, non si può fuggire, e così Greta si ritrova a scavare nella storia della sua famiglia, tornando laggiù dove tutto è cominciato. Dall’autore di Fra me e te, un romanzo che ci riporta a vicende dei Balcani di ieri e che ci insegna tanto anche sull’oggi, mettendoci in guardia dal fatto che la paura (in questo caso del diverso per religione) può diventare odio e persino guerra. E che ci restituisce con tocco lieve e potente insieme un ritratto di ragazzi stupendi, capaci di ripartire, di sognare un futuro diverso, oltre ogni frontiera e distanza.
A Srebrenica, nel 1995, viene scritta una delle pagine più nere della storia europea degli ultimi settant’anni. Ma Greta non ne sa quasi nulla: lei, nata a Milano, è concentrata sulla scuola e sulla sua passione, il nuoto. Non è mai stata in Bosnia, anche se metà della sua famiglia viene da lì. Non sa nulla dell’infanzia di suo padre Edin, delle intere giornate che ha passato, lui musulmano, a giocare nei boschi con Goran, l’inseparabile amico serbo. Dal passato, però, non si può fuggire, e così Greta si ritrova a scavare nella storia della sua famiglia, tornando laggiù dove tutto è cominciato. Dall’autore di Fra me e te, un romanzo che ci riporta a vicende dei Balcani di ieri e che ci insegna tanto anche sull’oggi, mettendoci in guardia dal fatto che la paura (in questo caso del diverso per religione) può diventare odio e persino guerra. E che ci restituisce con tocco lieve e potente insieme un ritratto di ragazzi stupendi, capaci di ripartire, di sognare un futuro diverso, oltre ogni frontiera e distanza.
Un pinguino a Trieste
Chiara Carminati, Bompiani
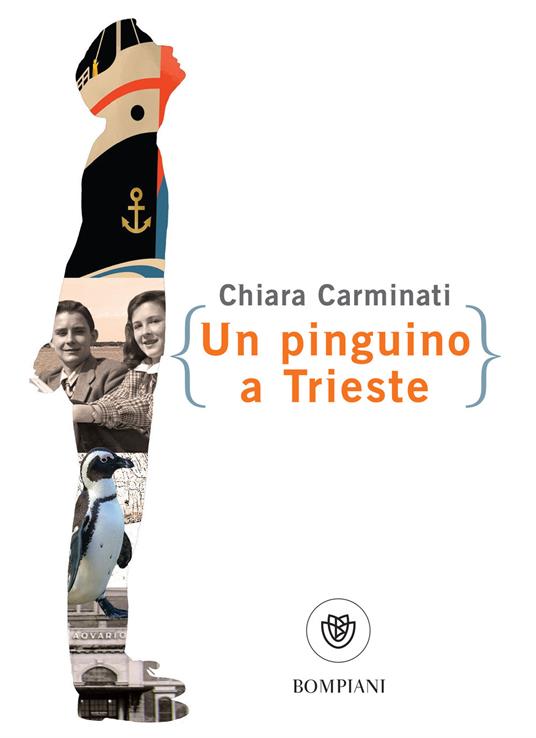 Sono molte le cose che Nicolò non sa di suo padre. Non sa dove si trovi, prima di tutto: in un campo di prigionia in Eritrea, così si diceva. Ma la guerra è finita e lui non è tornato. Quando un articolo di giornale lascia intravvedere un’altra possibilità, per inseguirla Nicolò s’imbarca come piccolo di camera sulla motonave Europa, undicimila tonnellate, velocità venti nodi, destinazione Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A quindici anni lascia tutto ciò che conosce: Trieste, lo zio Franco che l’ha ospitato e l’ha fatto studiare, Irma, la bella sarta che gli fa da sorella maggiore e da confidente. A bordo affronta mille regole, lavora con persone che gli vogliono bene e con persone che lo detestano, e incontra Susanna, capelli di cannella, lentiggini come miele, occhi verdissimi dietro le lenti, da subito sua complice. E a terra, in città sconosciute – Durban, Cape Town – dove si parlano lingue sconosciute, insegue, solo e ostinato, la pista che lo porterà davanti a un uomo segnato dal dolore. Un romanzo di crescita e di scoperta del mondo, ideale compagno di Fuori fuoco, con cui ha in comune lo stile limpido e la tessitura fitta e precisa di storia, cronaca e immaginazione: e c’è posto anche per un piccolo pinguino vero, clandestino a bordo dell’Europa e poi consegnato a una lunga, onorata carriera come mascotte della città di Trieste.
Sono molte le cose che Nicolò non sa di suo padre. Non sa dove si trovi, prima di tutto: in un campo di prigionia in Eritrea, così si diceva. Ma la guerra è finita e lui non è tornato. Quando un articolo di giornale lascia intravvedere un’altra possibilità, per inseguirla Nicolò s’imbarca come piccolo di camera sulla motonave Europa, undicimila tonnellate, velocità venti nodi, destinazione Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A quindici anni lascia tutto ciò che conosce: Trieste, lo zio Franco che l’ha ospitato e l’ha fatto studiare, Irma, la bella sarta che gli fa da sorella maggiore e da confidente. A bordo affronta mille regole, lavora con persone che gli vogliono bene e con persone che lo detestano, e incontra Susanna, capelli di cannella, lentiggini come miele, occhi verdissimi dietro le lenti, da subito sua complice. E a terra, in città sconosciute – Durban, Cape Town – dove si parlano lingue sconosciute, insegue, solo e ostinato, la pista che lo porterà davanti a un uomo segnato dal dolore. Un romanzo di crescita e di scoperta del mondo, ideale compagno di Fuori fuoco, con cui ha in comune lo stile limpido e la tessitura fitta e precisa di storia, cronaca e immaginazione: e c’è posto anche per un piccolo pinguino vero, clandestino a bordo dell’Europa e poi consegnato a una lunga, onorata carriera come mascotte della città di Trieste.
La vegetazione rappresenta uno strumento essenziale per la creazione di città ecologicamente ed economicamente sostenibili in quanto sono in grado di ridurre l’entropia dell’ambiente antropico.
L’Istituto nazionale di statistica (Istat) definisce il verde urbano come un patrimonio di aree verdi che insiste sul territorio dei Comuni gestito, direttamente o indirettamente, da Enti pubblici quali i Comuni, le Province, le Regioni o lo Stato. In questo ambito sono compresi diversi tipi di aree verdi: verde attrezzato, parchi urbani, verde storico, aree di arredo urbano e aree speciali comprendenti giardini scolastici, orti botanici, vivai, giardini zoologici e altre categorie residuali.
Con il termine servizi ecosistemici si intende la capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente o indirettamente, i bisogni dell’uomo e garantiscano la vita di tutte le specie.
Le infrastrutture verdi migliorano le condizioni microclimatiche urbane, la qualità dell’aria, la resilienza della città e la salute psico-fisica dei cittadini, in particolar modo di coloro che risiedono in aree densamente popolate. Inoltre, garantiscono il mantenimento della biodiversità locale.
La vegetazione in città e, specialmente, le siepi, grazie alla loro naturale capacità fonoassorbente, sono in grado di ridurre il livello e la percezione dei rumori generati dalle attività umane. Nel 2013, il progetto europeo Hosanna ha evidenziato che una cintura di alberi di 15 metri riduce i livelli del rumore di 3 decibel.
Gli alberi mitigano il clima urbano in quanto riducono l’isola di calore attraverso l’assorbimento di calore da parte delle foglie, l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione che consiste nell’assorbimento dell’acqua da parte delle radici e nella restituzione di quest’ultima sotto forma di vapore acqueo dopo la fotosintesi.
Tale processo è endotermico poiché sottrae l’energia all’ambiente esterno causando un decremento della temperatura intorno alle piante durante le ore più calde e un innalzamento dell’umidità atmosferica. Attraverso tali processi la temperatura dell’aria negli spazi verdi urbani può essere da 1- 3 °C fino a un massimo di 5-7 °C più bassa delle aree urbane edificate circostanti. La vegetazione, infatti, è in grado di svolgere il ruolo di termoregolatore.
La vegetazione è in grado di ridurre l’erosione idrica superficiale e il rischio idrogeologico in quanto assorbe una parte delle piogge, che poi vengono rilasciate gradualmente sia nelle falde idriche sotterranee che nei corpi idrici superficiali.
Le infrastrutture verdi possono essere progettate per la rinaturalizzazione di aree da destinare alla laminazione delle piene e per il ripristino di zone umide perifluviali attraverso la ricostruzione degli spazi funzionali all’equilibrio fluviale.
Gli alberi svolgono la funzione igienico – sanitaria in quanto depurano chimicamente l’atmosfera, fissano i gas tossici, filtrano le polveri sottili e gli altri agenti inquinanti.
Nel dettaglio, l’inquinante maggiormente captato dalle specie vegetali è rappresentato dal particolato atmosferico. Gli inquinanti sono fissati dalle specie vegetali in concentrazioni differenti in base alla
micromorfologia dell’apparato fogliare, come ad esempio la quantità di tricomi, la presenza di cere superficiali o lo spessore della cuticola.
Infatti, le foglie aventi un’elevata quantità di tricomi intercettano il particolato grossolano o avente dimensioni superiori ai 10 µm, mentre disdegnano quello fine. Le foglie cerose, invece, trattengono il particolato fine.
La capacità delle piante di agire come filtri attivi nei confronti del particolato atmosferico è direttamente proporzionale alla vicinanza con il suolo. La stagionalità, invece, non rappresenta un parametro chiave.
Alcune piante svolgono la funzione di ripristino ambientale e di recupero di siti inquinati da contaminanti di varia natura.
Il valore storico e culturale intrinseco delle infrastrutture verdi è rappresentato dalla capacità di schermare la vista dei palazzi, di valorizzare i monumenti, di migliorare gli ambienti domestici e lavorativi, di influire sulla salute fisica e mentale delle persone e di diversificare il paesaggio.
L’albero è dunque una risorsa biologica, ambientale, energetica e sociale avente una funzione strategica nello sviluppo sostenibile delle città.
Le specie vegetali rilasciano i composti organici di origine biogenica (BVOC), ovvero una varietà di sostanze chimiche volatili aventi una vasta gamma di funzioni per le piante, e di conseguenze per l’ecosistema e l’ambiente.
Tali composti rappresentano, quindi, l’alfabeto con cui le piante comunicano con l’ambiente e, in particolare, con le specie animali. Infatti, tali sostanze attraggono specifici impollinatori e proteggono le specie vegetali dai patogeni grazie alle loro proprietà repellenti, deterrenti, antimicrobiche e antifungine.
Infine, tali composti proteggono le piante dagli stress abiotici in quanto sono dei potenti antiossidanti. Si rileva, infatti, che le specie emettitrici di BVOV sono in grado di adattarsi maggiormente ai cambiamenti climatici.
L’isoprene, i monoterpeni ed i sesquiterpeni rappresentano gli unici BVOC in grado di influenzare la qualità dell’aria in quanto interagendo con gli altri gas atmosferici possono incrementare la formazione del particolato atmosferico e dell’ozono, potente gas serra e inquinante tossico in grado di ridurre significativamente le produzioni colturali e forestali.
I composti volatili svolgono un ruolo fondamentale nelle aree caratterizzate da elevate concentrazioni di azoto, come quelle urbane e perurbane, in quanto l’isoprene contribuisce alla formazione dell’ozono a livello del suolo, mentre i monoterpeni e i sesquiterpeni incrementano la presenza del particolato atmosferico.
Nel dettaglio, in presenza di forte irraggiamento solare, le reazioni fotochimiche fra tali composti e gli ossidi di azoto possono causare l’inquinamento fotochimico e, conseguentemente, la formazione di ozono, perossiacetilnitrato (PAN), perossibenzoil nitrato e altre sostanze secondarie.
Le condizioni ottimali per la formazione di ozono sussistono quando il rapporto tra i composti organici e gli ossidi di azoto è compreso fra 4 e 15, mentre viene limitato dalla bassa concentrazione di quest’ultimi o di VOC. Nelle città si verificano le condizioni ottimali in quanto i composti organici voltatili sono determinati sia da fattori antropici (ad es. veicoli, incenerimento dei rifiuti, processi di combustione) e sia da quelli naturali (vegetazione).
Si ritiene necessario rilevare che la rimozione di ozono troposferico ad opera delle piante ne supera la produzione durante il periodo notturno in quanto le concentrazioni di ossidi di azoto sono tendenzialmente minori e le emissioni di isoprene, essendo luce e temperatura dipendente, non si verificano.
Infine, occorre evidenziare che le specie vegetali con scarsa capacità emissiva sono anche quelle meno resistenti all’ambiente urbano.
In questi ultimi anni molte associazioni, comitati e cittadini hanno ritenuto che la forestazione può rappresentare una soluzione al cambiamento climatico.
L’assorbimento di anidride carbonica da parte delle specie vegetali è connesso alla loro strategia di crescita, alla necessità di estrazione dei nutrienti dal suolo e alla loro capacità di adattarsi ai mutamenti climatici.
L’incremento delle temperature, infatti, accentua i processi di respirazione rispetto a quelli di fotosintesi clorofilliana da parte delle piante, riducendo la capacità di stoccaggio dell’anidride carbonica. La riduzione della conduttanza stomatica, indispensabile per mantenere la quantità di acqua necessaria alla fisiologia della pianta, riduce gli scambi con l’atmosfera e, conseguentemente, l’accumulo e la fissazione di anidride carbonica da parte delle specie vegetali.
La diminuzione delle precipitazioni, invece, ha modificato le caratteristiche chimiche, biogeochimiche e di evapotraspirazione dei suoli sfavorendo i processi vitali delle piante stesse e favorendo i processi di decomposizione organica e la conseguente emissione di anidride carbonica in atmosfera.
La gestione del verde nelle città, purtroppo, non tiene in considerazione le esternalità positive e gli impatti sopra descritti.
Si rappresenta che esistono differenze specie-specifiche nella capacità di sequestro del carbonio, di captazione del particolato atmosferico e di emissioni dei BVOC. Infatti, l’emissione di composti organici di origine biogenica e l’assorbimento di anidride carbonica non è costante poiché è connessa allo stato fisiologico e alla fenologia della pianta.
In particolare, le specie arboree più efficaci per il sequestro e lo stoccaggio del carbonio sono il Pioppo bianco e la farnia Quercus robur, mentre per la rimozione di biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio e ossigeno sono ottimali il Pino domestico, l’Ippocastano ed il Pioppo bianco.
I Tigli ed il Bagolaro rappresentano le specie aventi capacità media di rimozione degli inquinanti e basso potenziale di formazione dell’ozono, specialmente negli ambienti urbani del Mediterraneo. Il cerro, l’ulivo e il frassino sono ideali per minimizzare la produzione di ozono, ma non sono vantaggiosi per l’assorbimento di anidride carbonica in quanto la crescita delle foglie e della massa legnosa è assai modesta e lenta.
Nella messa a dimora delle nuove alberature, inoltre, occorre considerare la loro dimensione finale nel tempo. Infatti a seconda dell’area di pertinenza e dello sviluppo potenziale degli alberi bisogna garantire la distanza minima tra le alberature dai 2 ai 6 metri di raggio.
In ambiente urbano, quindi, la pianificazione delle infrastrutture verdi è fondamentale in quanto permette di massimizzarne i benefici e di ridurne gli impatti.
Gli Enti locali dovrebbero effettuare il censimento del verde, il monitoraggio delle alberature, le cure e gli interventi adeguati, incluse le operazioni di potatura e anche di abbattimento che siano necessarie. Tali operazioni però devono effettuate con la perizia necessaria e, quindi, devono essere evitate le potature tramite capitozzatura o gli abbattimenti effettuati durante la stagione di nidificazione dell’avifauna anche in assenza di ragioni di somma urgenza.
Occorre, altresì, evitare modelli di gestione monoculturale del verde urbano e incrementare la presenza dello strato di vegetazione inferiore, come ad es. gli arbusti e rampicanti, al fine di aumentare la biodiversità e di ridurre gli impatti ambientali determinati dal depauperamento delle falde acquifere profonde e dall’instabilità idrogeologica.
Figura emblematica del passaggio epocale che l’Italia affronta con la fine del XIX secolo, Galileo Chini ne incarna pienamente le caratteristiche e le contraddizioni sul piano artistico e culturale. Chini appartiene infatti a quella generazione di artisti che deve fare i conti con il rapporto tra arte e industria, che si interroga su come poter sviluppare la produzione in serie senza perdere un alto livello qualitativo dei propri prodotti, che indaga la possibilità di creare uno stile “nazionale” in grado di fondere la tradizione latamente medievale e rinascimentale delle arti decorative ottocentesche con il nuovo linguaggio modernista. Riscopriamo questo artista poliedrico, insieme al cocuratore della mostra Galileo Chini. Ceramiche tra Liberty e Déco, attualmente in corso al MIC, Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, a cura di Valerio Terraroli e Claudia Casale.
La prima formazione artistica di Galileo Chini, nato a Firenze nel 1873, è segnata dalla pratica diretta sul patrimonio artistico medievale e rinascimentale di Firenze determinata dal fatto che, in seguito alla morte a breve distanza dei genitori, Galileo viene preso a lavorare come garzone nel laboratorio dello zio Dario, noto restauratore, il quale decide di occuparsi del nipote iscrivendolo alla Scuola Professionale di Arti decorative e Industriali di Firenze, nella quale il giovane si forma nella copia e nella rielaborazione del repertorio medievale e rinascimentale fiorentino.
Del resto proprio a quel repertorio si ispirano molti architetti, artigiani, artisti e decoratori, i quali si trovano a dover rispondere sia alle molte commesse pubbliche, dovute ai grandi lavori di risanamento della città, ma, soprattutto, alla numerosa e influente comunità inglese e americana, che la visita o vi risiede stabilmente, e che riconosce in quelle scelte decorative, sia nelle architetture sia negli oggetti, dei valori identitari alternativi, nei loro caratteri storicisti o pseudo tali, rispetto a ciò che stava avvenendo a livello europeo con l’affermarsi di un nuovo orizzonte del gusto, orientato ad un gusto decorativo ispirato alla vitalità della natura, all’interno della “rivoluzione modernista”.
Tra le attività del settore ceramico che, più di altre, basano la propria fortuna sul revival storico e possono vantare una relazione privilegiata con l’elite anglosassone figurano la manifattura Cantagalli e la manifattura Ginori di Doccia. Ulisse Cantagalli, convinto sostenitore delle teorie morrisiane ispiratrici dei londinesi Arts & Crafts, promuove, dal 1878, una produzione eccellente, rispetto alla tradizione famigliare in origine più specializzata nella cottura delle terre che nella produzione di ceramiche artistiche, riorganizzando gli ambienti di lavoro, predisponendo gli spazi per la decantazione, la battitura, la lavorazione al tornio, le fornaci per il biscotto, per il terzo fuoco e diverse muffole per smalti e vernici.
Se la Cantagalli continua per diversi decenni a offrire al pubblico una produzione esclusivamente incentrata sul revival del patrimonio quattrocentesco e rinascimentale, la manifattura Ginori, già sul finire degli anni settanta dell’Ottocento, mostra una maggiore attenzione verso le innovative istanze moderne che iniziano ad emergere nelle esposizioni universali e nazionali, ma, a causa di problemi gestionali mai risolti, viene acquistata dall’industriale ceramico milanese Augusto Richard e nel 1896 nasce la Società Ceramica Richard-Ginori.
Secondo le testimonianze autobiografiche è questo il motivo che spinge Galileo Chini, verso la fine del 1896, a fondare, assieme a Giovanni Montelatici, Vittorio Giunti e Giovanni Vannuzzi, la manifattura L’Arte della Ceramica con l’ambizione di rinverdire i fasti dalla ceramica smaltata e invetriata dei Della Robbia, ma declinandola entro le linee del gusto moderno sia nella produzione di vasi ornamentali e oggetti di arredo domestico, sia negli apparati decorativi architettonici, e scegliendo, strategicamente, di aprirne il negozio in via Tornabuoni. Dunque, così come Ulisse Cantagalli sceglie di porre la propria sala espositiva a fianco dei propri laboratori per poter legare la propria immagine commerciale a un tipo di lavoro percepito come artigianale e quindi autentico, Galileo e i suoi soci scelgono di consolidare un’immagine moderna e internazionale di L’Arte della ceramica attraverso un punto vendita arredato secondo le linee del gusto art nouveau e nel cuore commerciale della Firenze contemporanea. Sempre nel 1896, uno dei soci, Giuseppe Montelatici, ispirandosi alla rivista d’arte “Gil Blas” avvia la pubblicazione del settimanale “Fiammetta”, nella quale pubblicano Ojetti, Angeli, Bontempelli e molti altri, con illustrazioni ideate da Kienerk, Fabbri, Signorini e Chini, ispirate ai modelli simbolisti e secessionisti europoei.
“Vittorio Giunti diventò il nostro direttore tecnico, io il direttore artistico, Giovanni Montelatici e Giovanni Vannuzzi i primi esecutori […] Vittorio fu l’ingegnere costruttore della piccola fornace nel cortile, io avevo già fatto le sagome dei vasi e pensavo già a queste e alla decorazione di darle un carattere proprio, vi erano già in Italia e in Firenze fabbriche di grande valore, a Firenze come Cantagalli, perciò il seguitare delle varie epoche si doveva escluderlo e cercare qualcosa di nuovo e intonato ai nostri tempi”.
Da queste considerazioni risulta evidente quanto l’esigenza di dar vita ad una manifattura ceramica di questo genere non sia tanto una sorta di revanscistico orgoglio locale a fronte del passaggio della gloriosa Ginori ad una proprietà industriale milanese, quanto dalla lucida consapevolezza che un’azienda ceramica, nata come cooperativa secondo il modello morissiano, capace di unire competenze tecniche artigianali di alto livello, sperimentazione tecnologiche prese da esperienze industriali, intelligenza creativa fondata su un’eccellente conoscenza dei repertori decorativi storicisti, ma aggiornata sui modelli pittorici moderni e sulle novità del gusto modernista, potesse avere la possibilità di aprire un nuovo mercato, soprattutto internazionale, connotando la propria produzione con la qualità della tradizione italiana declinata secondo i parametri dello stile moderno.
A questa fase appartengono maioliche e ceramiche smaltate e invetriate di diversa ispirazione che rivelano quanto le fonti iconografiche e stilistiche siano ancora venate di qualche sfumatura storicista che velocemente si stempera in formulazioni organicamente più affini agli stilemi art nouveau anche se la pittura preraffaellita risulta essere la matrice più riconoscibile in questa fase di avvio delle invenzioni pittoriche di Galileo per la manifattura ceramica. Alla produzione di piatti ornamentali con soggetti femminili ispirati alla pittura preraffaellita e ad una sorta di linea neobotticelliana [1], successivamente arricchita dall’impiego dei lustri metallici e proseguita fino a tutti gli anni Venti, si affiancano vasi a forma di anfora le cui anse sono plasticamente modellate come serpenti che attorcigliano il proprio corpo, ispirate alle maioliche rinascimentali, con un fregio pittorico nel quale profili femminili e di fauni o una coppia di centauri si alternano su un fondo di paesaggio o, più modernamente, gli elementi plastici si sciolgono in decori pittorici in cui gli elementi floreali si dispongono sulla superficie del vaso in modo asimmetrico, come nastri avvolgenti, decisamente modernisti. […]

[1] Piatto decorativo con testa femminile e girasoli, 1896-1898, Arte della Ceramica, collezione privata
Tra il 1898-1900 L’Arte della Ceramica avvia l’esecuzione di pannelli ornamentali, costituiti da piastrelle dipinte, nei quali profili e volti preraffaelliti si stagliano su girali di foglie e fiori [2], e di vasi nei quali la struttura decorativa, di soggetto floreale, non è solamente un abbellimento di forme tradizionali, ma spesso ne determina la trasformazione espandendosi plasticamente nelle anse e nelle imboccature dando vita ad un’organica relazione tra corpo plastico e decorazione pittorica. Il segno è sempre preciso, graficamente rilevato, e gli elementi naturalistici, ordinati in ritmiche composizioni che rimandano ai tessuti prodotti su disegno di William Morris e Walter Crane per gli Arts & Crafts, assumono talvolta l’effetto “colpo di frusta” e una sorta di lineare semplificazione affine a certe proposte della grammatica secessionista monacense, documentata nelle pagine della diffusissima rivista “Jugend”.

[2] Pannello ceramico con due teste femminili fiori e grappoli d’uva, 1898-1902, Arte della Ceramica, Galleria Expertise di Cinelli Marzio
Così la pittura risulta stesa sulle superfici sia in campiture uniformi, perfettamente circoscritte da una sottile line di contorno, sia per piccoli tocchi di pennello, più o meno ravvicinati, allo scopo di creare effetti di sfumato affini alla pittura vera e propria, magari con l’impiego di lustri, come nei piatti in cui il volto di una sirena, o di una ninfa o di una giovane donna, si gira a guardare lo spettatore e la cui espressione stupita e venata di malinconia è resa nello sfumare della guancia e dello zigomo e dalle ciocche di capelli mosse che sembrano metamorfizzarsi in una sorta di avvolgente moto ondoso.
La prima partecipazione della giovane manifattura ad un evento espositivo nazionale è quello alla Prima esposizione di arte decorativa moderna, organizzata a Torino nel 1898, nella quale essa ottiene la medaglia d’oro, a pari merito con le manifatture toscane Cantagalli e Bondi di Signa, le quali, però, presentano ancora un repertorio storicista ed eclettico dando la misura di quanto la battaglia tra gusto storicista e stile moderno non sia ancora terminata.
Tuttavia, le novità proposte da Chini vengono immediatamente colte dai più avveduti critici del momento, ossia Leonardo Bistolfi, Ugo Ojetti, Enrico Thovez e, in particolare, da Anna Piccola Menegazzi che, con lo pseudonimo di Mara Antelling, pubblica un significativo intervento nella rivista “Arte Italiana Decorativa e Industriale” che sottolinea la perfetta corrispondenza delle invenzioni ceramiche di Galileo Chini con il gusto modernista già ben delineato anche in Italia: “Chi ha dato un vero tuffo nel moderno attingendo però a piene mani alle sottili gentilezze del preraffaellismo e specialmente alle grazie del Botticelli è stata la Società Fiorentina “L’Arte della Ceramica”.
Anche qui una tavolozza calma, fresca, nell’intonazione tenera dei versi. Nessun stridore, un’abbondanza di gialli pallidi, di azzurri, di violetti, di rosa tenacissimi. Una fioritura larga uno spampanamento di petali che si adagiano nelle corrette forme dei vasi, forma svariatissime, le quali vanno dalle anfore e dai boccali di birra ad uso di Fiandra, fino agli orci medicei. In mezzo alla decorazione floreale di iridi e di papaveri verdi o gialli, spiccano i profili virginei di teste femminili, di delicatezza eterea, o ridono satiri, di un riso diabolico, contrasto violento con la dolcezza dei visi muliebri”.
Del resto, Sem Benelli nel gennaio del 1899 di “Emporium” (1899, pp. 74-78) attesta ulteriormente quanto i nuovi linguaggi stilistici di impronta modernista si siano ormai radicati definitivamente anche in terra toscana e quanto le invenzioni di Chini siano la punta di diamante di questa scelta. L’ulteriore affermazione, questa volta internazionale, con l’ottenimento del Grand Prix d’Honneur per le arti decorative e la medaglia d’oro all’Esposizione Universale di Parigi del 1900, conferma il successo, anche commerciale, della manifattura fiorentina avendo in questa occasione affiancato alla produzione di vasi, cache-pot e brocche o versatoi, piastrelle per rivestimenti sia di esterni sia di interni.
Anche se il successo non stabilizza i bilanci della cooperativa, il 7 marzo 1898 L’Arte della Ceramica raggiunge la sua definitiva costituzione legale come “società”, abbandonando la sua prima natura di “cooperativa”. Tale cambiamento, però, genera a sua volta risentimenti tra chi, come Montelatici, crede ancora fortemente nella possibilità di continuare un’attività dettata esclusivamente da fratellanza e comunione d’intenti. È proprio a causa del progressivo allontanamento di Montelatici che, dal marchio di fabbrica, scompare il simbolo delle mani intrecciate, emblema della fraterna amicizia dei quattro fondatori e caratteristica delle segnature di tutti i manufatti che vengono prodotti entro e non oltre il 1898; permane invece, fino al 1909, quando ormai nessuno degli iniziatori dell’attività è più presente nella manifattura, il simbolo della melagrana con il monogramma “ADCF” o “ADC”.
Galileo Chini ricopre il ruolo di direttore artistico della manifattura L’Arte della Ceramica tra il 1897 e il 1904, la quale, in contemporanea con l’esposizione di Torino del 1902, assume la denominazione di Ceramica Fontebuoni. Le sue invenzioni, dai grandi vasi decorativi ai piatti da parata, dalle ciotole alle anfore, sono una testimonianza, come si è detto, dell’influsso della pittura preraffaellita e dei modelli morissiani nella cultura dell’arte decorativa italiana, per la quale i valori fondativi sono la dimensione artigianale del lavoro, l’indissolubile unità tra arte e vita, l’idea della sostanziale unicità dei singoli pezzi che, seppur prodotti serialmente, vengono decorati a mano.
Ciò dimostra, al di là delle prese di posizione teoriche, quanto l’Italia sia ancora lontana, a queste date, dall’idea di industrializzazione e di produzione meccanica dei pezzi, come invece già avviene in Germania nell’ambito del Deutscher Werkbund. Del resto è significativo che Chini proponga un vastissimo repertorio di forme e di tecniche decorative che spaziano dalle citazioni della gloriosa stagione rinascimentale della maiolica italiana, come le anse anguiformi o fitomorfe che divengono un continuum con la parte pittorica, all’impiego dei lustri metallici, già del resto proposti dalla manifattura fiorentina di Ulisse Cantagalli a partire dal 1878, dai repertori naturalistici di insetti, fiori e piante palustri ai motivi stilizzati della coda di pavone [3], del fiore di cardo, della palmetta, fino ad arrivare a decori squisitamente grafici o, al più, di ispirazione alla ceramica greca arcaica, con i vasi in grès decorati con la tecnica al sale in blu o in verde su fondo chiaro che Galileo continuerà a produrre anche nella nuova manifattura Fornaci di San Lorenzo, gestita insieme ai cugini fino al 1925. Negli stessi anni, altri centri produttivi in Italia cercano di adottare la nuova formula decorativa modernista, per quanto in ritardo rispetto alla media europea, ma senza coglierne la profonda ventata di rinnovamento linguistico e tecnico, anche per la sostanziale separazione della produzione ceramica, tranne i rari casi di Cantagalli, Chini e delle manifatture milanesi, dalla contemporanea invenzione architettonica. […]

[3] Vaso a bulbo con “occhio di penna di pavone”, 1919-1925, Fornaci Borgo San Lorenzo, MIC Faenza, inv. n. 20190
La contrapposizione, ma anche la continuità, fra tradizione e modernità, è ben rappresentata dalla personalità artistica di Galileo Chini, ma su questo tema si assiste anche ad un vivace confronto sul piano teorico da parte di Agnoldomenico Pica, Alfredo Melani, Enrico Thovez, Roberto Papini, Adolfo Venturi e Ugo Ojetti, benché ognuno di loro, con sfumature diverse, sostenga la medesima necessità per lo sviluppo delle arti decorative italiane, di un’articolata e moderna formazione per gli artigiani, dell’organizzazione di esposizioni nazionali e internazionali per diffondere sia il gusto del bello sia il mercato, la creazione di repertori di riferimento, l’adozione da parte delle manifatture, anche industriali, di un direttore artistico che garantisca la qualità e l’originalità della produzione e una sostanziale fusione tra le arti, in altre parole l’adozione rigorosa di uno stile moderno con risvolti anche di educazione sociale e di recupero delle tradizioni e dei valori popolari. […]
Il nuovo assetto societario dell’Arte della Ceramica voluto dal maggior finanziatore della manifattura, il conte ferrarese Vincenzo Giustiniani, induce, nel 1904, alle dimissioni di Galileo, in qualità di direttore artistico, seguito dal cugino Chino, direttore tecnico, nel 1905. Tuttavia, sulla base delle esperienze maturate e dei riconoscimenti ottenuti, i Chini decidono di investire nell’apertura di una propria manifattura industriale ceramica e vetraria (grande passione di Chino) nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, che prende il nome di Fornaci San Lorenzo e che sceglie come marchio, ironicamente, la griglia stilizzata evocante il martirio del santo eponimo.
Inizia così una nuova stagione creativa di Galileo che elabora una serie ricchissima di disegni per le decorazioni sia delle maioliche a lustri, sia dei grès: si tratta di progetti ornamentali per vasi, anche di monumentali dimensioni, cache-pot, ciotole, alzate, versatoi, contenitori di varia foggia, calamai e rivestimenti in piastrelle sia dipinte a lustri, sia modellate plasticamente e smaltate. Il repertorio si è fatto estremamente stilizzato, al limite del decoro geometrico, e a tratti astrattizzante, scegliendo talvolta smalti monocromi entro una griglia rigorosamente cartesiana.
I temi fitomorfi risultano aver perso l’andamento flessuoso e avvolgente per assestarsi in composizioni simmetriche, arcaicizzanti, specie nei grès al sale dipinti con il blu cobalto (eseguiti sotto l’attenta perizia tecnica di Chino) e nei quali i motivi sono ripresi dalla ceramica greca arcaica, nella regolare divisione orizzontale in fasce ornamentali, oppure si presentano come tappeti musivi certo suggeriti dall’onda lunga del lessico secessionista, soprattutto austriaco, e dall’impatto che su Galileo hanno le scelte decorative e compositive presenti nelle opere mature di Gustav Klimt esposte alla Biennale veneziana (1910) e alla mostra internazionale del cinquantenario del regno a Roma (1911) [4].

[4] Vaso con rose stilizzate, 1906-1911, Fornaci Borgo San Lorenzo, collezione privata Pistoia
L’orizzonte decorativo di Chini aveva già iniziato a virare, intorno al 1902, verso una grammatica secessionista sua propria in cui confluiscono non solo suggestioni da Monaco e da Vienna, ma anche suggerimenti provenienti dalla profonda conoscenza delle xilografie e dei repertori pittorici giapponesi e da una specifica evoluzione interna dei temi fitomorfi e zoomorfi che si liberano definitivamente di cadenze asimmetriche e avvolgenti […] in favore di quella geometrizzazione del segno e di quell’esuberanza decorativa che sono un preludio al gusto art déco. A partire dalla fine degli anni Dieci, Chini propone per la manifattura Fornaci San Lorenzo invenzioni decorative rinnovate e nutrite dalla straordinaria esperienza in Oriente che Galileo vive tra il 1911 e il 1913 durante il monumentale cantiere aperto a Bangkok per la decorazione del palazzo Reale di re Rama VI. […]
L’approdo ad un maturo e specifico lessico déco lo si ha con la progettazione e la realizzazione dell’apparto decorativo (maioliche, vetrate, pitture murali, superfici musive, ferri battuti, arredi) per lo Stabilimento Termale Lorenzo Berzieri a Salsomaggiore Terme, impresa conclusasi nel 1923, nella quale eredità secessioniste e klimtiane ed esuberanze orientali si sposano in uno dei più affascinanti esempi dell’Art Déco italiana, ma la parabola dell’impegno nell’ambito della produzione ceramica di Galileo Chini si sta concludendo. Gli atti finali coincidono, simbolicamente, con la codificazione internazionale del gusto déco, ossia la Seconda Biennale delle arti decorative di Monza e, soprattutto, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes di Parigi, ambedue nel 1925.
Dopo queste due esperienze espositive e con la proposta di opere originali per tenuta decorativa e intelligenza creativa, Galileo decide di dedicarsi esclusivamente alla pittura, probabilmente un desiderio che coltivava da un po’ di tempo, lasciando la manifattura di famiglia che viene presa in carico dai figli di Chino, Tito e Augusto, e per la quale quest’ultimo, in particolare, si impegna nella rinnovo del campionario, sostanzialmente adattandolo ad una produzione industriale in cui spesso riemergono ancora echi dei disegni e delle proposte decorative di Galileo che restano nell’archivio della manifattura.
Nella pittura di cavalletto e nella grande decorazione Chini adotta, fin dai primissimi anni del Novecento, la tecnica del Divisionismo, su modello di Previati, Segantini, Pellizza da Volpedo, ricorrendo però agli stilemi lineari e avvolgenti e alle composizioni asimmetriche tipici delle secessioni europee; del resto, già nel 1904 aveva esposto alla Secessione di Monaco. Galileo Chini, nel corso della sua inesausta attività, ha collaborato con scultori e architetti tra cui Domenico Trentacoste, Edoardo De Albertis, Guido Calori, Sirio Tofanari, Ugo Giusti, Adolfo Coppedè, Giovanni Michelazzi, Alfredo Belluomini; così come nel settore della scenografia ha avuto stretti rapporti di amicizia e di collaborazione con Sem Benelli e con Giacomo Puccini, per il quale mette a disposizione la sua originale esperienza in Estremo Oriente per l’allestimento scenico dell’opera Turandot nel 1926. Muore nel 1956, dopo un trentennio dedicato pressoché esclusivamente alla pittura, nella sua casa fiorentina.
Una mostra per Galileo Chini
A Galileo Chini, inventore di ceramiche d’arte, che ha attraversato con intelligenza creativa e in quasi un trentennio le radicali trasformazioni del gusto e le complesse relazioni tra arte e industria che hanno caratterizzato il dibattito critico europeo sulla sostanza, la funzione e lo status delle arti decorative tra il 1890 e il 1925, il Museo Internazionale della Ceramica MIC di Faenza ha voluto dedicare una grande mostra co-curata dallo storico dell’arte Valerio Terraroli e dalla direttrice del Museo, Claudia Casali, con l’obiettivo di evidenziare e mettere in luce, pur nella sua poliedrica attività, lo specifico della ceramica d’arte di Galileo Chini. In questa occasione vengono presentati al pubblico, fino al 14 maggio 2023, circa 300 pezzi, tra ceramiche e disegni, espressioni del complesso e fascinoso universo creativo di un artista/designer protagonista delle mutazioni dell’arte italiana tra Simbolismo, Liberty, Secessione ed Art Déco.
Il MIC
Il Museo internazionale della ceramica MIC di Faenza è la più importante raccolta al mondo dedicata alla ceramica: ospita 60mila opere, che vanno dai 4000 anni a.C. ai giorni nostri. Comprende opere della penisola italiana dal Medioevo all’Ottocento, del Vicino Oriente Antico, di area mediterranea in epoca ellenistica, manifatture precolombiane e islamiche. Un’ampia sezione è dedicata alla ceramica moderna e contemporanea. A cadenza biennale, il museo promuove un concorso internazionale di ceramica artistica, che gli consente di ampliare le sue raccolte con opere provenienti da tutto il mondo.
In copertina: Piatto ornamentale con testa femminile e pavone, 1898-1902, Arte della Ceramica, collezione privata
La letteratura è piena di riferimenti al Natale e all’ultima parte dell’anno, dall’atmosfera tanto magica e suggestiva per tutte le età. La rivista di questo mese vi propone schede pronte da utilizzare in classe per parlare del Natale attraverso romanzi, poesie e molto altro.
Secondaria di 2° grado Secondaria di secondo grado Economia politica Scienza delle finanze

Il contenuto è protetto da password
Contatta la tua agenzia di zona per richiedere il codice d'accesso
Secondaria di 2° grado Istituto Tecnico Indirizzo AFM e Articolazioni SIA e RIM Economia Aziendale

Il contenuto è protetto da password
Contatta la tua agenzia di zona per richiedere il codice d'accesso