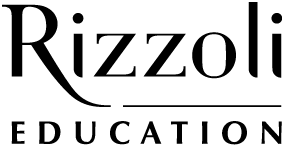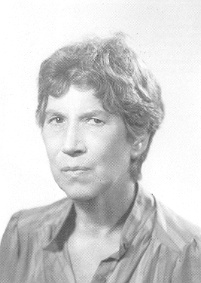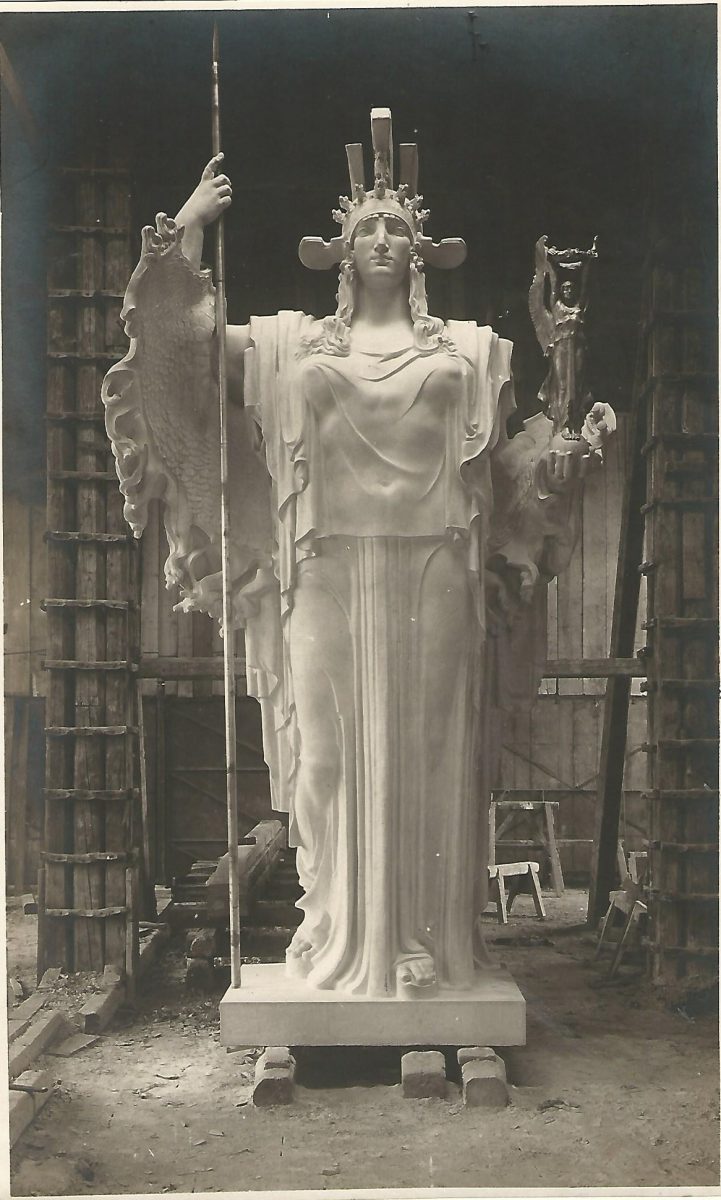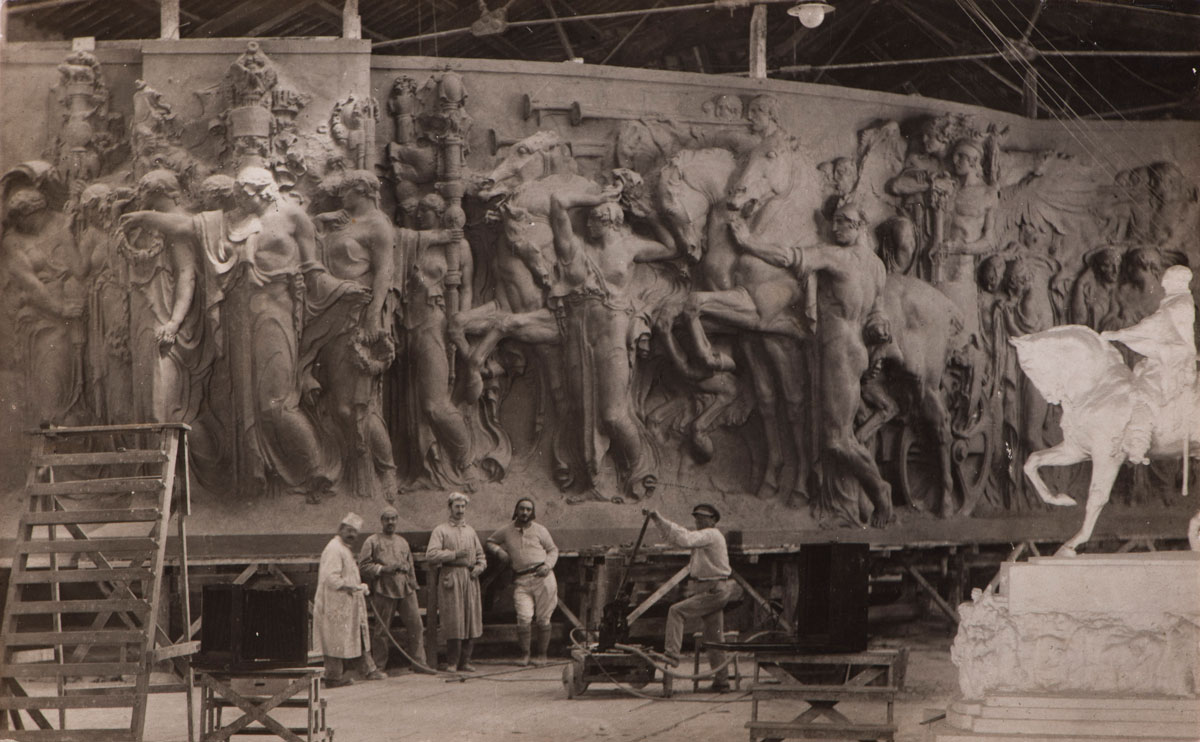Una delle discriminanti più evidenti tra chi padroneggia una lingua con scioltezza e chi la sta ancora apprendendo è l’ampiezza del vocabolario. La varietà e l’ampiezza del vocabolario sono due parametri decisivi per distinguere il parlante esperto dal principiante.
Quando si insegna una L2, in particolare quando ci si occupa di Inglese alla scuola primaria, è facile incappare nell’errore di fornire “grandi categorie di significato” facilmente spendibili, vocaboli generici e utilizzabili fin da subito, che danno al parlante l’impressione – reale – di essere in grado di comunicare immediatamente, ma che, se non vengono nel corso di apprendimenti successivi “raffinate” e articolate, possono portare ad una conoscenza della lingua superficiale, vaga e ad una comunicazione così basilare da risultare quasi banale.
Le emozioni e i verbi: un universo di possibilità
Pensiamo, solo per citare alcuni esempi, al vocabolario relativo alle emozioni. Ovviamente i primi vocaboli che gli insegnanti presentano ai bambini sono generici e rappresentano categorie ampie e poco definite: happy, sad, angry… queste macro-espressioni vanno benissimo per il parlante alle prime armi, ma persino i bambini più piccoli si rendono benissimo conto che c’e’ una bella differenza tra la felicità che si prova scoprendo che un grande ci ha preparato una torta, e la felicità che prova chi ha vinto un grosso premio alla lotteria, solo per fare un esempio. Se da un lato il primo sarà pleased, delighted o glad, il secondo sarà invece overjoyed o exultant. Allo stesso modo, a seconda del grado di sete, avremo chi, lentamente, sips, chi gulps quasi senza prendere fiato, chi, semplicemente, drinks, senza connotazioni di sorta.
Verbi ed aggettivi – soprattutto quelli legati alle emozioni -, tanto nella Lingua madre quanto nella L2, sono categorie grammaticali perfette per lavorare non solo sull’ampliamento del vocabolario, ma anche sulla percezione dei vissuti, sulla riflessione sui propri sentimenti, sull’articolazione elaborata e precisa del proprio pensiero. Vediamo come.
Ragionare sulla Lingua Madre come punto di partenza
Senza voler scomodare una L2, la conoscenza della propria lingua da parte dei bambini e’ talvolta poco profonda e variegata. Il primo passo per parlare e scrivere meglio è conoscere e usare tanti vocaboli che rappresentino diverse sfumature dello stesso significato. Ecco alcuni esempi di verbi – sicuramente non completi, ma per rendere l’idea:
- MANGIARE: assaggiare, piluccare, sbocconcellare, divorare, rimpinzarsi…
- PIANGERE: piagnucolare, frignare, singhiozzare, gemere…
- CAMMINARE: vagabondare, trascinarsi, procedere, marciare, incedere…
- DORMIRE: sonnecchiare, appisolarsi, assopirsi, ronfare…
- GUARDARE: sbirciare, avvistare, squadrare, contemplare, fissare…
Queste sono solo alcune possibilita’ da cui partire per lavorare. L’insegnante potra’:
- Fornire ai bambini alcune “liste” di esempio, chiedendo loro di discutere in piccoli gruppi sulle differenze di significato tra i vari elementi della lista;
- Chiedere ai bambini di ampliare le liste presentate, aggiungendo altri sinonimi che loro stessi conoscono;
- Offrire a ciascun gruppo un particolare verbo da utilizzare per creare una nuova lista, introducendo l’uso del dizionario dei sinonimi e contrari;
- Chiedere a ciascun bambino di creare una frase per ciascuna delle variazioni presenti sulla sua lista, in modo che le frasi stesse mettano in evidenza le sfumature di significato.
Riconoscere l’esistenza delle sfumature di significato nella L2
Dopo aver lavorato sulla L1, il passaggio alla L2 dovrebbe essere abbastanza naturale. Usando un vocabolario a doppia entrata, l’insegnante potrà lavorare per insegnare ai bambini a cercare le traduzioni dei verbi e degli aggettivi identificati nella prima fase del lavoro. Ciascun bambino passerà poi a creare sul proprio quaderno una pagina per ciascun parola in cui, ponendo il vocabolo di riferimento al centro, si disegnerà intorno uno schema a ragnatela all’interno del quale saranno inseriti tutti i sinonimi trovati, aggiungendo dei disegni che li rappresentino, e magari una frase in L2. In questo modo si creeranno delle vere e proprie pagine di vocabolario personalizzato che, poiché uniscono la parola all’immagine, saranno molto più facili da memorizzare.
Creare le carte delle “gradazioni di parole”
Usando degli schemi che ricordano i campioni di colori di vernice presenti nei colorifici, l’insegnante inviterà i bambini a disporre i sinonimi di verbi ed aggettivi che hanno trovato in ordine di intensità. Come già detto sopra, abbuffarsi è molto diverso da piluccare, ed è ancora diverso da saziarsi, e imparare a distinguere tra i diversi gradi di profondità delle parole aiuta a diventare parlanti esperti sia nella L1 sia nella L2. Come classe, o in gruppi, i bambini coloreranno gli schemi (allegati) con diverse gradazioni di colore, dopodiché li riempiranno con le parole che hanno tradotto nell’attività precedente. Ogni schema può essere ritagliato su misura, poiché non tutte le parole hanno lo stesso numero di possibili sinonimi. Questi “arcobaleni di significato” potranno essere poi appesi in classe e restare sempre a disposizione come riferimenti lessicali.
Costruire un mazzo di “sinonimi visivi”
Utilizzando i bambini come modelli, il docente potrà realizzare, con un semplice strumento fotografico, dei mazzi di carte che rappresentino visivamente le variazioni di significato di ciascuna parola. A mensa, per esempio, si potrà fotografare qualcuno che sbocconcella, qualcuno che si abbuffa, qualcuno che assaggia. In palestra alcuni bambini saranno fotografati mentre marciano, altri mentre si trascinano altri ancora mentre gironzolano… Tutte queste carte potranno essere poi usate per il ripasso del vocabolario, estratte a caso, utilizzate come quiz veloci, o come giochi per creare semplici storie, magari estraendone due o tre in ordine sparso e chiedendo agli studenti di utilizzare i vocaboli pescati per creare semplici situazioni narrative.
Sfumature di significato a San Valentino
La ricorrenza di San Valentino si presta molto bene a introdurre il lavoro fin qui presentato sulle gradazioni di significato. Riprendendo l’adagio (foro noto più agli insegnanti che ai bambini) “Mi ami? Ma quanto mi ami?” è possibile selezionare un vocabolario specifico e coinvolgente da cui partire a lavorare:
- TO LOVE: to care, ro enjoy, to be crazy about, to admire, to venerate…
- TO HUG: to cuddle, to squeeze, tu clasp, to hold…
- HAPPY: cheerful, merry, joyous, satisfied, overjoyed…
- BEAUTIFUL: pretty, good-looking, charming, gorgeous, stunning…
Le possibilità sono infinite, così come le circostanze. Quello che però non cambia è l’importanza di fornire ai bambini un vocabolario il più ampio e specifico possibile, per permettere loro di esprimersi realmente secondo le necessità e intenzioni del loro pensiero, a prescindere da quale lingua essi decidano di utilizzare.