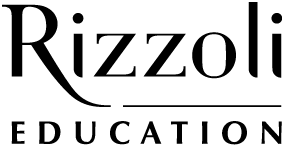Per parlare del tema di questo mese abbiamo deciso di mettere mano allo strumento più studiato e meno conosciuto dell’Universo: il cervello.
Secondo un articolo non più recentissimo, pubblicato su Nature Neuroscience nel 2012, la scienza ci può dire con estrema precisione se e quanto siamo inclusivi.
Procediamo con ordine.
In un esperimento curato dal team di Elizabeth A Phelps della New York University, è stato analizzato il cervello di un buon numero di persone in seguito alla visione di alcune foto riguardanti volti di etnie differenti.
Conclusione: quando venivano mostrate foto con volti diversi dalla propria etnia, nel cervello si attivava l’area “della paura”. Si tratta di una semplificazione, ovviamente, ma la sostanza è questa: il nostro cervello sembra essere stato programmato per essere decisamente poco inclusivo.
Prima di dichiararci sconfitti e cambiare mestiere, però, è bene considerare la seconda fase dell’esperimento.
Phelps e il suo team hanno condotto la stessa prova ma, questa volta, mostrando volti di personaggi famosi. Il risultato in questo caso è stato molto diverso. Le nuove foto hanno prodotto nel cervello effetti molto più rassicuranti, dimostrando alcune evidenze che ci portano a parlare del lavoro che svolgiamo quotidianamente a scuola.
La ricerca del 2012 ci dice che il nostro cervello si è evoluto in un’epoca lontanissima e violenta, quando la diversità era associata a “clan” ostili. Allo stesso tempo, però, si è saputo adattare alle sollecitazioni della modernità dimostrando di saper definire come “conosciuto” anche chi non appartiene alla nostra stessa etnia.
Il lavoro di tutti i giorni, in questo senso, è fondamentale perché allarga il confine di questo ambito conosciuto: non solo il calciatore famoso o l’attore e l’attrice, ma anche il vicino di banco, la sua famiglia e potenzialmente qualsiasi persona.
Le neuroscienze confermano, semmai ce ne fosse bisogno, che l’inclusione non è un’opzione, ma una necessità sociale e una scelta culturale da praticare giorno per giorno.
E giorno per giorno abbiamo l’impegno di educare alle differenze.
Non solo cromatiche, ovviamente.
Differenze, appunto, non diversità.
Si è diversi quando c’è uno standard di riferimento considerato “normale”. La diversità vuole la preposizione “DA”.
Si è differenti , invece, tutti e tutte; le differenze sono normali TRA le persone, NEL gruppo.
Una questione di preposizioni che cela una grande questione educativa.
La vera inclusione è quella che parte dalle differenze: a scuola è quella che si pratica con lo Universal Design for Learning.
Una didattica pensata per tutti e per tutte, universale, appunto.
Colorata, certo: una didattica a colori, per poter soddisfare tutte le sfumature presenti nel nostro dipinto-classe.
La didattica a colori, da oggi la chiameremo così, è quella che:
- organizza bene l’ambiente di apprendimento, immaginando ogni possibile bisogno durante l’attività;
- mette in campo una buona ridondanza di risorse e materiali, che i bambini e le bambine gestiranno in modo libero e autonomo, in base alle esigenze e alle curiosità;
- propone compiti e progetti aperti, di senso, stimolanti, che non prevedano una unica “soluzione giusta”, ma che possano essere svolti in tanti modi diversi, ciascuno sfruttando le proprie potenzialità e i propri interessi;
- fa leva sulla creatività e sul pensiero divergente: parte da un percorso comune di conoscenze e abilità, ma invita ciascun bambino e ciascuna bambina a inventare combinazioni cromatiche differenti per mettere in campo soluzioni e idee, per diventare più competenti.
La didattica a colori richiede maestria, da parte nostra. Ma in fondo, siamo maestri e maestre: è la nostra sfida!